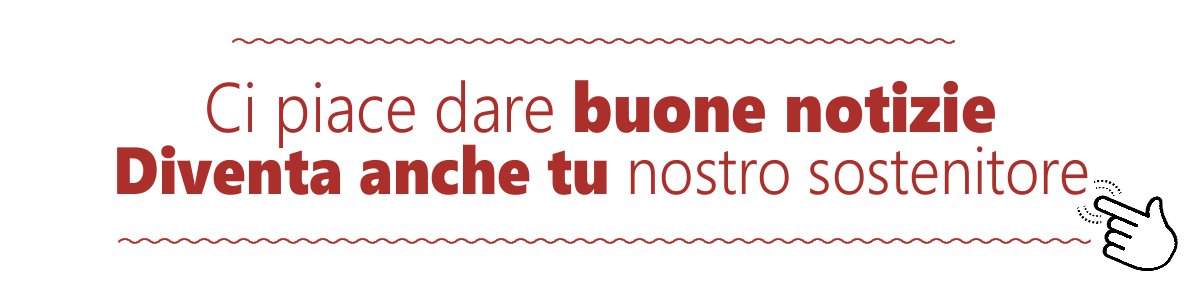Papa Francesco. De Simone: “Nel Mediterraneo la teologia può contribuire a costruire la pace”
“Il discorso di Papa Francesco a Napoli è stato importante, non solo per il Mediterraneo, ma per un rinnovamento della teologia. È diventato un punto di riferimento nel dibattito sulla necessità di ripensare la teologia, di adottare un deciso cambio di paradigma”, evidenzia al Sir la docente alla Facoltà teologica di Napoli, sezione San Luigi, e co-coordinatrice della Rete teologica mediterranea

Papa Francesco, nell’incontro del 21 giugno 2019 alla Facoltà teologica di Napoli, richiamò il compito della teologia “di costruire su tutto il bacino mediterraneo una ‘grande tenda di pace’ dove possono convivere nel rispetto reciproco i diversi figli del comune padre Abramo”. Il Pontefice ci lascia in eredità anche l’importanza di guardare l’altro non con sospetto, ma come un fratello, un richiamo al quale anche la teologia deve contribuire. Ne parliamo con la teologa Pina De Simone, docente alla Pontificia Facoltà teologica di Napoli, sezione San Luigi; coordina, con Patrice Chocholski, la Rete teologica mediterranea.
Oggi che Francesco ci ha lasciato che significato assume il mandato di costruire una teologia dal Mediterraneo?
Direi che oggi questo mandato assume il significato di una consegna e di una eredità da custodire e da far fiorire in tutte le sue potenzialità.
Il discorso di Papa Francesco a Napoli è stato importante, non solo per il Mediterraneo, ma per un rinnovamento della teologia. È diventato un punto di riferimento nel dibattito sulla necessità di ripensare la teologia, di adottare un deciso cambio di paradigma.Quel discorso, letto insieme al Proemio della Veritatis Gaudium e alla Ad Theologiam promovendam, traccia le linee di una teologia che ha il coraggio di stare tra la gente, che si costruisce ascoltando la vita delle persone e dei popoli. La teologia non può che essere una teologia della vita, dentro la storia, capace di rintracciare nella storia e nelle nostre storie la presenza operante della grazia, il soffio dello Spirito. Fare teologia nel Mediterraneo significa allora, prima di tutto, ascoltare il grido, la domanda di pace che viene dalla vita dei popoli di questo mare di mezzo, tornato ad essere mare di conflitti, luogo in cui si consuma, nell’indifferenza generale, un naufragio di civiltà. Il più grande cimitero d’Europa, a motivo dei respingimenti e dei naufragi, ma anche, purtroppo, per le guerre che ne insanguinano le coste.Eppure, questo mare è, da sempre, “mare del meticciato” – come Papa Francesco amava definirlo – e i popoli che vivono sulle sue coste hanno una lunga consuetudine di scambio e di reciproca contaminazione culturale.La teologia non può restare indifferente ai processi di disumanizzazione in atto, alla sistematica distruzione dei legami, all’esplosione di una violenza senza fine, giustificata da ragioni politiche e di difesa delle nazioni. Ascoltare quello che la vita dei popoli esprime vuol dire raccogliere il desiderio di pace, saperne argomentare le ragioni e mostrare la possibilità di percorsi culturali, sociali e politici.
C’è bisogno di una nuova narrazione del Mediterraneo ci ha detto il Papa a Napoli, una narrazione in cui riconoscersi e che sia principio di speranza. La teologia può e deve contribuire a questa narrazione.
Qual è stato il contributo di Papa Francesco per una cultura dell’accoglienza, della pace e dell’armonia tra i popoli nel Mediterraneo?
Papa Francesco non si è mai stancato di sottolineare il significato profondo del Mediterraneo quale crocevia, spazio di incontro tra popoli, culture, fedi diverse.
I suoi viaggi, i gesti da lui compiuti, oltre che le sue parole, sono stati annuncio e testimonianza concreta del valore dell’incontro che il Mediterraneo ha saputo esprimere nella sua storia e nelle culture che ad esso appartengono. L’incontro è reale quando è fatto di accoglienza e di mutuo riconoscimento, quando diventa scambio di doni, riconoscendo il valore dell’altro, della sua storia, della sua cultura, della sua fede. È quello che Papa Francesco ha chiesto continuamente nel riportare l’attenzione sul dramma dei migranti e questo fin dal suo primo viaggio a Lampedusa.
I continui appelli per la pace da parte di Papa Francesco purtroppo sono stati disattesi, ma sono un impegno a cui sono chiamate oggi più che mai tutta la Chiesa e tutta la società?
Purtroppo ci stiamo abituando a sentir parlare di guerra, di riarmo, come se fosse normale aumentare la produzione di armi, riempire gli arsenali, investire buona parte delle risorse di un Paese per difendersi da ipotetici nemici. Ci dicono che ragionare in questi termini è aderire alla realtà, prendere coscienza di una situazione internazionale sempre più complicata. Papa Francesco ci ha invitato ad avere invece un altro sguardo sulla vita comune, sui rapporti tra i popoli e le nazioni e soprattutto ad avere un’altra considerazione della realtà, di quella realtà che è superiore all’idea e alle ideologie di ogni tipo.
La realtà da imparare a vedere è il desiderio di pace che ci portiamo nel cuore e che tutti i popoli esprimono.
Un desiderio che chiede di essere ascoltato attraverso il coraggio di scelte che creino le condizioni per la pace: scelte di giustizia, di rispetto, di cooperazione e non di sfruttamento o di dominio, modi diversi di immaginare l’economia e i sistemi di produzione. Basta rileggere la Fratelli tutti o la Laudato si’ per capire che cosa vuol dire costruire la pace, il fatto che sognare un mondo di pace e impegnarsi perché sia possibile è, in verità, la forma di più alto realismo.
In che modo possono contribuire i teologi nella costruzione di un mondo di pace?
La teologia può contribuire alla costruzione di un mondo di pace ricordando che siamo fatti per la vita e non per la morte, può farlo contribuendo a risvegliare le coscienze, a rendere sensibili al dolore dell’altro, alle sue sofferenze, ma anche alle sue attese e ai suoi bisogni.
Educare a riconoscere l’altro e ad accoglierne il dono, formare alla giustizia e alla responsabilità per la storia comune sono sicuramente impegni che la teologia può assumere a partire dal compito che è suo proprio: quello di una intelligenza della fede che sappia dirne la forza trasformatrice e umanizzante. Ma la teologia può contribuire a costruire un mondo di pace facendosi essa stessa percorso di pace nello stile e nel metodo che adotta. Una teologia che si costruisce sinodalmente e in dialogo è già, di per sé, testimonianza di pace, segno di fraternità.
Nel vostro impegno per una teologia dal Mediterraneo come avete tradotto l’indicazione del Pontefice di generare percorsi di fraternità?
Nella Rete teologica mediterranea che coinvolge teologi e teologhe delle cinque sponde del Mediterraneo, abbiamo accolto l’invito di Papa Francesco a lavorare in rete, a pensare insieme, incrociando gli sguardi e le sensibilità culturali, facendo tesoro gli uni dell’esperienza degli altri, imparando a conoscerci e a stimarci, scoprendo sempre di più la ricchezza che c’è nella diversità delle storie e delle culture, ma anche dentro la Chiesa, tra Chiese orientali e Chiese di rito latino ad esempio. Stiamo imparando sempre di più che soltanto imparando ad ascoltarci e ad ascoltare insieme questo tempo che viviamo diventeremo capaci di leggerlo alla luce del Vangelo.
Il dialogo tra le religioni in che modo si deve accompagnare al dialogo tra le culture?
Il dialogo è la strada maestra per la pace e dialogo vuol dire mutuo riconoscimento e mutuo scambio di doni.
Il dialogo è scambio, incontro che arricchisce e fa crescere mettendo in comune ciò che si è, ma anche imparando nello scambio e nel confronto a conoscere l’altro e a conoscere ancor di più ciò che ciascuno è nella sua specificità. Questo vale per le religioni, ma vale anche per le culture. Nessuna pretesa di superiorità, nessuna forma di implicita assimilazione, ma il desiderio di essere insieme nella diversità, per camminare verso quella verità che possiamo cercare soltanto insieme e che è sempre più grande di noi.
La vostra rete tra Istituti teologici del Mediterraneo favorisce anche un dialogo tra le Chiese da cui provenite?
La Rete teologica mediterranea è dentro il cammino di tessitura di una Rete ecclesiale mediterranea che Papa Francesco aveva così tanto a cuore.
Il Mediterraneo è un contesto privilegiato in cui vivere la sinodalità tra le Chiese perché contesto di contesti e perché attraversato da grandi sfide che soltanto insieme possono essere affrontate.
Siamo sicuri che anche il lavoro teologico, se condotto sinodalmente come stiamo cercando di fare, può contribuire a questo percorso. La teologia dal Mediterraneo ha un profondo radicamento ecclesiale e mira proprio a rendere più saldo il rapporto tra il pensiero teologico e i vissuti ecclesiali. Anche le commissioni di ricerca che, come Rete, abbiamo avviato quest’anno, attraverso i temi di cui si occuperanno – le ferite e la riconciliazione della memoria, la teologia pubblica, la relazione con l’Islam, il contributo delle Chiese orientali -, sono chiara espressione di questo nesso che ci sta particolarmente a cuore.
Lei ha partecipato anche al Sinodo, ha un suo ricordo particolare di Papa Francesco?
Di Papa Francesco ricordo il tratto semplice e paterno, la presenza attenta in mezzo a noi, il sorriso, le battute e la grande fiducia che sapeva trasmettere.
Ricordo di avergli detto che venivo dalla Facoltà di Napoli, da San Luigi dove lui era stato. “È una bella Facoltà – mi ha detto -, una Facoltà che mi piace”. E quando gli ho detto che stavamo portando avanti l’impegno per una teologia dal Mediterraneo ha affermato: “Certamente, bisogna continuare”. Le sue parole ora mi risuonano ancora di più nel cuore.