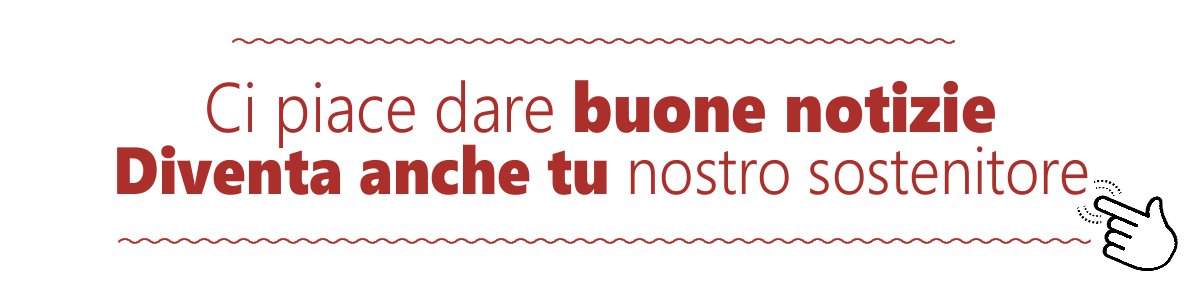Il giardino chiuso. Ottocento anni di vita monastica nella biblioteca dell’abbazia di St. Marienthal
Un’esposizione unica nel suo genere, che accompagna i visitatori alla scoperta dei tesori del monastero di St. Marienthal, in Lusazia, che per la prima volta vengono esposti al pubblico

“Giardino chiuso tu sei, sorella mia, mia sposa, sorgente chiusa, fontana sigillata. I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, con i frutti più squisiti, alberi di cipro e nardo, nardo e zafferano, cannella e cinnamomo, con ogni specie di alberi d’incenso, mirra e aloe, con tutti gli aromi migliori. Fontana che irrora i giardini, pozzo d’acque vive che sgorgano dal Libano”. (Ct 4,12-15)
Sembra quasi di sentirli i profumi del giardino chiuso che viene descritto con così grande dovizia di particolari nel quarto capitolo del Cantico dei Cantici. Un passo, questo, che ha ispirato per secoli i religiosi e la loro vita fatta di preghiera e lavoro, di riposo e studio.
E sembra quasi di sentire il profumo dei libri, quelli antichi, sfogliando sull’account Ig della Slub, la biblioteca universitaria del Land di Sassonia, le immagini che raccontano l’inaugurazione, martedì 28 gennaio, della mostra interamente dedicata a “Il giardino chiuso”. Un’esposizione unica nel suo genere, che accompagna i visitatori alla scoperta dei tesori del monastero di St. Marienthal, in Lusazia, che per la prima volta vengono esposti al pubblico. Si tratta di testi che raccontano ottocento anni di vita monastica.
L’abbazia di St. Marienthal è un’abbazia cistercense femminile, situata nell’Oberlausitz, in Sassonia. È il più antico monastero femminile dell’ordine cistercense in Germania. Si trova circa 20 km a nord di Görlitz, nel territorio comunale di Ostritz, sulla riva sinistra del fiume Neiße, che dal 1945 costituisce la linea di confine tra la Germania e la Polonia.
Nonostante i tanti periodi di crisi e le distruzioni subite, le monache hanno sempre difeso e preservato la loro biblioteca, che è giunta intatta fino a noi, oggi, otto secoli dopo la fondazione del monastero. Si parla di 2.700 manoscritti e di migliaia di libri, risalenti a quasi mille anni fa, che ne fanno una collezione culturale e storica di immenso valore. Un segno, questo, di quanto importanti siano stati nel tempo i libri per la trasmissione della fede, dell’identità culturale e della conoscenza, soprattutto nei monasteri, che fino a tutto il XIX secolo sono stati, insieme alle scuole generali, i principali centri educativi.
Tante le traversie che hanno segnato, nel corso dei secoli, la vita del monastero di St. Marienthal e della sua comunità. Non da ultimo la grande ristrutturazione che ha preso il via a partire dal 1989 e per la quale la comunità monastica ha speso molti mezzi ed energie. Una volta terminati i lavori sembrava che finalmente si potesse tirare un po’ il fiato. Ma poi, nell’agosto del 2010, una terribile alluvione ha procurato gravissimi danni all’intero complesso in cui oggi vivono 15 suore. Per far fronte ai nuovi lavori – quantificati in diversi milioni di euro – le monache si sono viste costrette a mettere in vendita i tesori preziosi di fede, cultura e storia conservati nella loro biblioteca.
Nel 2023, la Slub (Sächsische Landesbibliothek Dresda), con il sostegno economico della Ernst von Siemens Art Foundation e della fondazione Carl Friedrich von Siemenz, ha acquistato per 5,5 milioni di euro tutti i manoscritti più importanti e i volumi più preziosi conservati finora della biblioteca di St. Marienthal. Una soluzione questa che ha permesso di preservare dalla dispersione un patrimonio di inestimabile valore e, al tempo stesso, lo ha messo a disposizione di tutti, anche di quanti, nel “giardino chiuso” del monastero non sono mai entrati.
Fino al prossimo 17 maggio si potranno ammirare i manoscritti più importanti e scoprire i pezzi più singolari della collezione di St. Marienthal visitando il Museo del libro della Slub di Dresda. Per chi, invece, non ha nell’immediato in programma un viaggio nella capitale della Sassonia, i social offrono un ricco assaggio della mostra.
Come in un monastero medievale, l’esposizione è architettonicamente divisa in due parti, secondo lo schema della “stanza nella stanza”, al centro della quale è esposto il pezzo più prezioso. È custodito in una vetrina ed è un volume di rara bellezza. Si tratta del Salterio di Marienthal. Un nome, questo che non è del tutto corretto. In realtà, infatti, il volume – inutile dirlo, interamente scritto e decorato a mano – proviene dal vicino monastero cistercense maschile di Altzella, alle cui cure, tra il 1100 e il 1380, furono affidate le monache di Marienthal. Con molta probabilità, durante la Riforma, l’abate di Altzella portò il codice e altri manoscritti di grande valore a Marienthal, salvandoli così dalla distruzione. Oggi è chiamato “Salterio di Marienthal” perché sono state le monache cistercensi a salvarlo e conservarlo attraverso i secoli. Il committente del Salterio, magnificamente decorato, lo deve aver fatto realizzare in uno scriptorium di Bamberga attorno al 1220/30, in un periodo antecedente allo stile merlato che caratterizza il volume e che – anche per questo – è ancor più prezioso.
Poco distante dal Salterio di Marienthal, si può ammirare il “Graduale Marienthaler”, il corale indispensabile per la liturgia. Il volume è aperto alla pagina dedicata al Salmo 52, dove spicca l’iniziale Q del “Quid glorias”, miniatura di rara bellezza in cui un grande drago, insieme ad altri draghetti più piccoli si intrecciano tra loro a delineare quasi una “forgiatura di intrighi”, che richiama al testo stesso del salmo.
Sotto la grande foto della biblioteca rococò del monastero fatta costruire nel 1752 dalla badessa Theresia von Stnfftleben (prima di allora la biblioteca si trovava in una torre in pietra, capace di proteggere i volumi in caso di incendio), si trova il lascito più “pesante” dell’intera collezione: un graduale di quattordici chili, alto 55 centimetri e largo 36, con centinaia di pagine in pergamena, protette da pesanti ornamenti in ottone e bordi metallici Un vero e proprio tomo, che si spera le monache non abbiano dovuto spostare troppo spesso dal leggio della chiesa del convento.
In mostra troviamo anche la pergamena con la prima menzione del monastero, datata 1234. Un documento, questo, che testimonia non solo la storia dell’abbazia, ma anche dei momenti difficili che ha dovuto attraversare. Più di due terzi della pergamena, infatti, sono andati distrutti dall’acqua e dal fuoco, a testimonianza di incendi e distruzioni che hanno segnato la vita del monastero nel corso dei secoli.
Osservando l’usura dei volumi in mostra, si riesce a comprendere quali erano i santi prediletti dalle monache. La pagina con santa Caterina, che godeva di grande popolarità nel monastero e che, come le monache, sposò il Salvatore come una sposa in cielo, mettendo un anello al dito come la badessa del monastero, è pesantemente usurata. San Crisogono, martire di Aquileia, posto sul lato opposto del volume in mostra e, soprattutto, il suo carnefice, invece, risplendono in colori quasi intonsi.
Ne “Il giardino chiuso” è possibile ammirare volumi e manoscritti di rara bellezza e valore, ma non solo. Viene, infatti, raccontata anche la vita quotidiana del convento, della scuola e della biblioteca di clausura, che comprende un numero sorprendentemente alto di brani profani. Tra le curiosità si racconta che nel 1810 è andata in scena nel monastero un’operetta, in onore del giorno dell’elezione della nuova badessa Laurentia Knothe. Ci sono poi raccolte musicali con le canzoni popolari che venivano insegnate ai bambini nella scuola del convento. In mostra ci sono anche due “Nonnentrompeten” – “trombe da monaca” o “trombe marina”, due grandi strumenti a corda (che nella forma ricordano quella di un contrabbasso e che erano dotati di una sola corda in budello), il cui suono è simile a quello di una tromba. Strumenti, questi, che si trovavano spesso nei monasteri femminili, dove era vietato suonare strumenti a fiato, perché considerati indecenti e osceni.