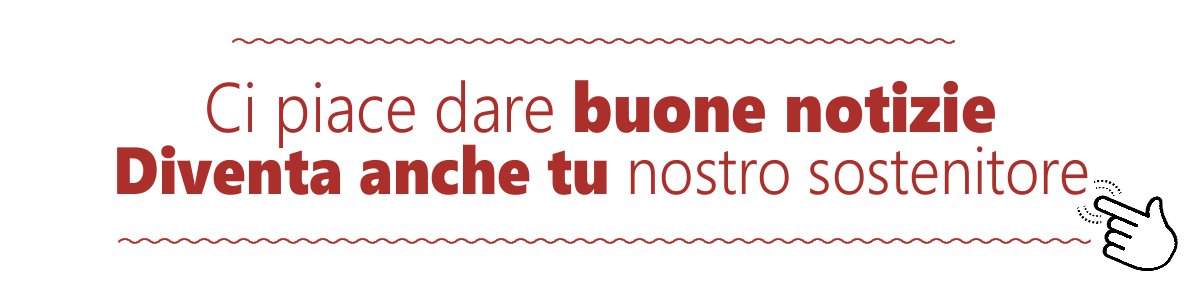Padova è medaglia d'oro per meriti sanitari durante la grande Guerra. Premio anche al prof. Gino Gerosa
Il presidente Mattarella ha accolto questa mattina al Quirinale il sindaco Sergio Giordani e il prof. Giampiero Avruscio dell'Azienda Ospedale Università e ha consegnato loro l'importante onorificenza. Padova si trasformò in una vera «città-ospedale» – recita la motivazione, sopperendo alla carenza di medici e approntando 8mila posti letto in edifici pubblici. Premiato anche il prof. Gino Gerosa per il primo impianto al mondo di un anello mitralico senza l'utilizzo della circolazione extracorporea

La città di Padova è da oggi insignita della Medaglia d’Oro «per il valore sanitario espresso durante la Grande Guerra». A ricevere, questa mattina, l’onorificenza, al Quirinale, il sindaco Sergio Giordani affiancato dal prof. Giampiero Avruscio dell’Azienda Ospedale Università di Padova, promotore dell’iniziativa che ha portato al prestigioso riconoscimento.
«Per i valori espressi nel campo sanitario e didattico durante la “Grande Guerra”, dove Padova si distinse nell’assistenza sanitaria, divenendo una vera e propria “Città ospedale militare” – si legge nella mortivazione – La città riuscì a sopperire alla carenza di medici impegnati al fronte, si approntarono circa 8 mila posti letto in edifici pubblici e privati, organizzando altresì corsi accelerati di medicina e chirurgia per oltre 1000 studenti provenienti da tutte le università italiane».
La nostra città durante la prima guerra mondiale fu per lungo tempo protagonista di quel conflitto, al punto da essere definita dagli storici «capitale al fronte». Meno noto, ma altrettanto importante fu il ruolo che Padova svolse in campo sanitario specie nella “sanità militare” che proprio qui divenne una vera e propria specialità medica. Fin dall'inizio della Grande Guerra Padova, per la presenza del polo ospedaliero e universitario, per la sua posizione geografica, relativamente vicina alle aree del conflitto, si venne a configurare come il principale riferimento sanitario militare, al punto che gli storici coniarono i termini di "città sanitaria" e di "città ospedale militare”.
«Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per questo prestigioso riconoscimento, che, finalmente, a oltre un secolo di distanza dai fatti, rende giustizia e riconosce il ruolo, il coraggio, la passione e anche il sacrificio, di centinaia e centinaia di uomini e donne, il cui impegno, nelle retrovie come al fronte, fu determinante nel portare aiuto e soccorso a quanti erano coinvolti in quel tragico conflitto che fu la Prima guerra mondiale – ha detto nel suo intervento il sindaco Giordani – Un impegno e una passione civile che scrissero una grande e bella pagina di storia. Un prestigioso riconoscimento quello tributato alla Città di Padova, ma che per noi significa riconoscere finalmente il contributo di tutti quei medici, quegli infermieri, quelle centinaia e centinaia di operatori che con il loro duro lavoro concorsero a curare i feriti, ad alleviarne il dolore, e spesso furono a loro vicini nel momento della morte».
Una missione che è rimasta nel dna della nostra sanità e che abbiamo visto quanto sia stata importante nella recente emergenza della pandemia Covid 19.
«Il Comitato "Padova medaglia d'oro al valore Sanitario" cui ho dato vita – ha commentato il prof. Avruscio – ringrazia le Istituzioni del Comune di Padova, Provincia e Regione che hanno deliberato la nostra proposta, chiedendo al Governo e al Ministero della Salute di riconoscere per Padova questo prestigioso riconoscimento. È un ulteriore tassello che si aggiunge alla gloriosa e nobile storia di Padova e della sua Comunità. Ulteriore notizia per Padova che giunge in un momento non certo facile, la stessa medaglia è stata consegnata ad personam al prof. Gino Gerosa per i meriti acquisiti nel campo della Cardiochirurgia».
Il quadro storico
La Medaglia d’Oro ricevuta oggi dalla Città di Padova, è un giusto riconoscimento che va a completare il quadro storico che vide Padova tra le grandi protagoniste di quell'epocale conflitto. Siamo soliti infatti evocare il ruolo di Padova quale Capitale al fronte, a seguito, dopo la rotta di Caporetto, del trasferimento provvisorio in città del Re, dello Stato Maggiore, nonchè dei comandi militari stranieri; così come, tanto sul piano storiografico, quanto nella memoria collettiva, si ricorda lo status di Padova quale città dell'Armistizio di Villa Giusti: Padova città della Pace.
In queste, pur corrette ricostruzioni e evocazioni, si era lasciato però sullo sfondo un altro importante tassello di questa grande e tragica vicenda collettiva. Ovvero il ruolo che la Città di Padova ricoprì nei primi terribili anni del conflitto, quando si trovò ad essere, per la sua collocazione geografica, il terminale ospedaliero e sanitario dell'esercito italiano, nonchè sede della famosa Università castrense. Non è certo un caso che il più imponente monumento, poi sacrario, eretto dai cittadini sia legato al tema della sanità: il Tempio della Pace, dove vennero raccolte le spoglie di 5.401 soldati, molti dei quali non morirono sul fronte, ma negli ospedali sparsi nel territorio.
Fin dall'inizio della Grande Guerra Padova, si venne a configurare come il principale riferimento sanitario militare. Oltre all'ospedale civile e a quello militare, da lungo tempo ospitato nell'ex Convento di via S. Giovanni da Verdara, vennero infatti allestiti in città moltissimi altri luoghi di ricovero. Si trattò di uno sforzo immane, che permise di realizzare circa 8.000 posti letto, cui se ne aggiungevano oltre 4.000 in altri comuni della provincia.
Si trattò di un’operazione logistica molto complessa, che il "Gruppo sanitario" realizzò in tempi molto brevi.
In pochi mesi si organizzarono infatti gli ottomila posti distribuiti in una ventina di ospedali. Ma non si trattava solo di predisporre le strutture. Non meno importante infatti era garantire la presenza di medici e del personale sanitario. Particolarmente critica era la carenza di medici. Il 26 novembre del 1916, con Regio decreto, si stabiliva così che gli studenti degli ultimi quattro anni dei corsi di medicina sotto le armi, in qualunque parte del regno fossero, dovessero essere inquadrati in uno specifico Battaglione universitario, costituito a Padova.
Il Battaglione era a tutti gli effetti un "corpo speciale", sottoposto direttamente al Comando Supremo. Il corpo insegnanti era costituito, in gran parte, dai docenti di medicina dell'Ateneo patavino. Preside ne era il clinico medico Prof. Luigi Lucatello.
Vi affluirono ben 1.332 studenti. Oltre alle aule di Medicina si allestirono aule didattiche in altri luoghi della città. L'Istituto d'Arte Pietro Selvatico, si trasformò così in spazio per la formazione dei giovani medici. In breve tempo si laurearono in medicina e chirurgia i primi 524 medici, gli altri si laurearono dopo il 1917: molti giovani studenti erano originari di Trento e Trieste. In quel periodo storico, una intera generazione di medici si laureò così a Padova.
La catena sanitaria era molto articolata. I feriti, dagli ospedali da campo e di tappa, arrivavano alla Stazione ferroviaria di Padova, che costituiva il primo nodo della rete. Qui, sotto le tettoie della Stazioni merci, erano previsti la prima sosta e il primo ricovero. Già dal 1915 la Croce Rossa aveva aperto in Stazione un posto di ristoro. L'enorme afflusso, giorno e notte, di feriti rendeva tuttavia insufficienti le ambulanze. L'Azienda tramviaria comunale realizzò così un apposito allacciamento, che permise di utilizzare i tram per il trasporto diretto dalla stazione agli ospedali.
Premiato anche il professor Gino Gerosa, direttore della Cardiochirurgia dell’Azienda-Ospedale Università di Padova, che ha ricevuto al Quirinale la Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica. Nel ringraziare, ha dedicato il riconoscimento al proprio impegno e a chi gli è stato vicino, compresi i figli a cui ha sottratto tempo. L’onorificenza celebra i suoi traguardi pionieristici, come il primo impianto al mondo di un anello mitralico senza circolazione extracorporea e il trapianto totalmente a cuore battente. Grazie a queste innovazioni, oggi anche in Italia decine di pazienti sono stati salvati con tecniche prima impensabili.
I 20 ospedali sorti in citta: 170 mila i ricoveri
In pochi mesi, in un concorso corale di solidarietà, moltissimi edifici civili e religiosi vennero trasformati in sedi ospedaliere, per l'accoglienza e la cura dei feriti. Oltre una ventina di ospedali diffusi in città, tra cui quello allestito nella Basilica di Santa Giustina, con ben 1.060 posti letti. L'ospedale civile, con i suoi 746 posti letto. Abbiamo ricordato l'Istituto d'Arte Selvatico, che si trasformò in ospedale con 630 posti.
Presso il Seminario vescovile la Croce Rossa predispose una struttura ospedaliera con 600 posti letto. All'interno dell'Ospedale psichiatrico provinciale si predisposero 370 posti. Le Scuole Carraresi divennero un ospedale con 290 posti; accanto a questi si registrano molte altre strutture, religiose e civili, che concorsero a realizzare una rete cittadina dell'assistenza decisamente impressionante.
Il numero dei ricoveri ci restituisce l'entità dello sforzo organizzativo e umano che fu realizzato da questa vera e propria cittadella sanitaria: i ricoverati furono infatti ben 170.000, tra feriti e ammalati. Trovarono soccorso e cure a Padova per un totale di 3.600.000 giorni di cura: dati che ci restituiscono l'entità di quel vero e proprio dramma, ma anche l'idea del grande impegno, della fatica, del dolore, della sofferenza di tutti coloro che furono protagonisti e artefici di questa vera e propria impresa collettiva.