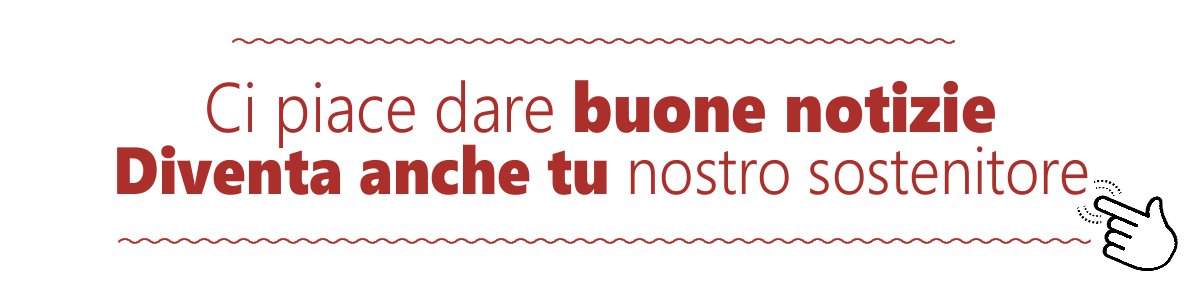Spiritualità: “Una solitudine ospitale”, intervista a Frédéric Vermorel, l’eremita contemporaneo
Nel cuore della modernità, tra il frastuono della vita quotidiana e la ricerca incessante di connessioni digitali, esiste ancora chi sceglie la solitudine come via di conoscenza e di ascolto. A raccontare al Sir la sua storia è Frédéric Vermorel, autore del libro “Una solitudine ospitale. Diario di un eremita contemporaneo”. E lo fa sfatando il mito dell'isolamento assoluto e offrendo una prospettiva su un'esistenza fatta di preghiera, riflessione e accoglienza che potrebbe riassumersi in due verbi: accogliere e ascoltare.

Nel cuore della modernità, tra il frastuono della vita quotidiana e la ricerca incessante di connessioni digitali, esiste ancora chi sceglie la solitudine come via di conoscenza e di ascolto. Frédéric Vermorel, autore del libro “Una solitudine ospitale. Diario di un eremita contemporaneo” (edizioni Terra Santa) e pubblicato per la prima volta nel 2021, racconta la sua esperienza di vita eremitica, sfatando il mito dell’isolamento assoluto e offrendo una prospettiva autentica su un’esistenza fatta di preghiera, riflessione e accoglienza.
Monaco eremita appartenente alla diocesi di Locri-Gerace, dopo anni trascorsi nell’eremo di Sant’Ilarione, nella Locride, attualmente vive nel territorio di Caulonia, comune della città metropolitana di Reggio Calabria.
Come può l’eremitaggio trovare una dimensione che consenta all’uomo di non cadere in una condizione di totale isolamento?
Dipende da diversi fattori. Innanzitutto, bisogna considerare che non esiste un’unica figura di eremita. Anzi, direi che la caratteristica principale della vita eremitica è proprio la sua estrema varietà. Per definizione, l’eremita è una persona sola, ma può comunque avere un legame: nel mio caso, ad esempio, sono un eremita diocesano e ho un legame con il mio vescovo e con la mia diocesi. Ci sono eremiti che appartengono a ordini religiosi e altri che non hanno alcun vincolo canonico, con ulteriori sfumature all’interno di queste categorie. Chiaramente, c’è una differenza tra chi vive in un isolamento quasi totale, con contatti ridottissimi – alcuni parlano solo con il proprio vescovo o padre spirituale – e chi, invece, come me, mantiene un legame costante con il mondo. Io, ad esempio, leggo quotidianamente i giornali in formato digitale, ricevo molta corrispondenza e pratico l’accoglienza. Alcuni eremiti la offrono, altri no. Non esiste una regola universale. Un aspetto importante da sottolineare è che, anche chi vive una condizione di reclusione quasi totale rispetto al mondo esterno, ha comunque una percezione di ciò che avviene nel mondo attraverso la preghiera e l’ascolto dello Spirito. È un aspetto molto difficile da definire perché oltrepassa quello che è strettamente razionale.
Nel suo libro racconta il percorso di discernimento che ha vissuto: un’esperienza illuminante, un diario ricco di riflessioni profonde. Potrebbe parlarcene?
Il discernimento avviene innanzitutto attraverso l’ascolto della Parola di Dio che si ‘concretizza’ attraverso l’imitazione di quella Parola che troviamo contenuta nella Bibbia, ma anche di un’altra Parola che troviamo nella storia, negli eventi e nelle esperienze vissute. È un aspetto che compare chiaramente nel mio libro. Non mi sono inventato eremita, né ho mai deciso consapevolmente di diventarlo. Mi sono semplicemente ritrovato a esserlo. Ho scoperto che in una determinata situazione mi sentivo a mio agio, che rispondeva a un anelito profondo del mio cuore di cui fino a poco tempo prima non ero consapevole. È stato un momento decisivo, un ascolto della vita e della Parola di Dio.
Come dicevano i Padri della Chiesa: “Illuminare la vita con la Parola, illuminare la Parola con la vita”. È in questa dinamica di ascolto che ciascuno scopre il progetto di Dio per sé.
Ha detto che lo sguardo dell’eremita è unito a tutti proprio perché separato. Come si è sviluppata questa prospettiva nei confronti del mondo?
Sicuramente c’è un affinamento della sensibilità, che avviene attraverso le esperienze vissute prima della vita eremitica. Nel mio caso, l’esperienza con le persone con disabilità nella Comunità dell’Arca, i soggiorni in Brasile e altre esperienze hanno contribuito a sviluppare un’attenzione profonda alla sofferenza e alla gioia delle persone. L’eremo è un luogo particolare, fatto di silenzio e di una relativa solitudine. Relativa perché, almeno nel mio caso e in quello di molti altri eremiti, riceviamo visitatori, ospiti o anche semplici passanti che restano per cinque minuti, mezz’ora o un’ora, condividendo un caffè, un momento di preghiera, una confidenza. Mi viene in mente l’espressione della teologa, scrittrice ed eremita, Adriana Zarri:
“L’eremo non è un guscio di lumaca, ma una conchiglia”, una cassa di risonanza.
Il silenzio e la solitudine fanno sì che le parole ascoltate in questo contesto risuonino più fortemente del frastuono di una metropolitana.
Ritiene che questa forma di vita possa essere ancora significativa per le vocazioni religiose?
Risponderei in due tempi. Anzitutto, non so se si possa davvero parlare di “scelta”. Si è scelti, ma non si sceglie in modo del tutto autonomo. Si accoglie una vocazione, la si riconosce e, una volta riconosciuta, la si fa propria. Quanto all’attualità della vita eremitica, ritengo che sia sempre stata e sempre sarà valida, finché esisterà la vita. Il bisogno di comprendere chi siamo, il mondo nel quale viviamo, il desiderio di solitudine e di ricongiungersi con la verità del nostro essere, con la nostra povertà, sono aspetti universali che abitano nel cuore dell’uomo e che prescindono da dove è nato e da quando è nato.
Per quanto tempo ha vissuto nell’eremo di Sant’Ilarione? E come trascorreva il suo tempo?
Sono arrivato a Sant’Ilarione, nella Locride, nell’aprile del 2003 e vi ho vissuto per quasi 22 anni. Da pochi mesi, però, non sono più lì perché sono in corso dei lavori che dureranno più di un anno. Attualmente vivo in una casetta nel territorio di Caulonia, senza vicini, perché le altre abitazioni sono abbandonate o vuote. La mia vita è molto semplice: preghiera, lavoro e accoglienza.
Potrebbe approfondire il concetto di “solitudine ospitale”?
La “solitudine ospitale” è l’identità ospitale di Gesù. Gesù è una persona ospitale, un concetto sviluppato dal teologo Christopher Hobart. Nel mio caso, ho ricevuto amore e accoglienza e, di conseguenza, sono chiamato a restituire ciò che ho ricevuto.
Un dono trattenuto che non viene restituito o condiviso si corrompe, proprio come un’acqua che smette di scorrere diventa imbevibile.
Dunque, la solitudine ospitale significa che chi vive una condizione di relativa solitudine o di ritiro dagli uomini ha comunque la porta sempre aperta, almeno idealmente. Naturalmente, come tutti gli esseri umani, ho i miei limiti, il mio carattere e le mie stanchezze, che talvolta rendono difficile essere ospitali come si vorrebbe. In fin dei conti, anche nel caso del recluso, che non è la mia condizione,
la solitudine deve essere ospitale
ossia deve saper accogliere quell’ospite per antonomasia che è Dio stesso e, in Lui, tutti gli esseri umani e addirittura l’intero creato.
Il silenzio è una dimensione centrale nella vita eremitica. Ha un consiglio da condividere a chi vorrebbe coltivarlo?
Molto concretamente, chi vive in città – come è stato il mio caso per diversi anni, a Parigi e Bruxelles – dovrebbe ritagliarsi tempi e spazi per il silenzio e il raccoglimento. È fondamentale per non disperdersi, per raccogliere i pezzi di sé e chiedersi: “Chi sono io?”. Senza questi momenti, si rischia una dispersione totale. Anche chi, per mille motivi di vita professionali o familiari, è costretto a convivere nel frastuono, può apprendere l’arte dell’abitare questo fragore in modo potenzialmente silenzioso. In fin dei conti il silenzio non è assenza totale di voci, di suoni, ma capacità di ascolto. È una disponibilità all’incontro. Nessuno è un superuomo o una superdonna. È essenziale trovare gli strumenti necessari per fare esperienza di quest’incontro.
Utilizza strumenti digitali da molti anni. Qual è il suo rapporto con essi?
Li abito con sapienza e prudenza. Sono strumenti straordinari, con potenzialità immense. Utilizzo Facebook da alcuni anni, il che potrebbe sorprendere. Lo vedo come un luogo di evangelizzazione digitale: quasi ogni giorno pubblico una meditazione biblica. Tuttavia, interagisco poco con le persone che non conosco, perché questi strumenti restano filtrati e gli scambi possono essere fuorvianti: dietro uno schermo o una tastiera, il rischio di fraintendimenti è alto. Il digitale resta ad ogni modo un possibile luogo di evangelizzazione che mi permette di offrire un piccolo contributo di condivisione della Parola.
Angela Servidio
(*) Parola di Vita