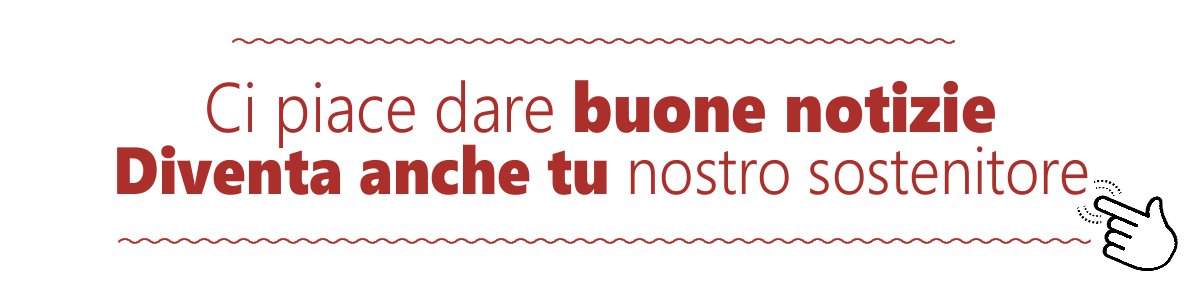Il ricordo di papa Francesco dei vescovi "padovani". Con lui, periferie meno fragili e dimenticate
Due mesi, o poco più, sono passati dalla scelta di papa Francesco di nominare don Riccardo Battocchio, vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto.

Era il 24 febbraio scorso e il già rettore dell’Almo Collegio Capranica andava così ad “aggiungersi” agli altri illustri presbiteri della Diocesi di Padova che in questi anni sono stati chiamati al ministero episcopale da Bergoglio, «un segno – come aveva sottolineato in quell’occasione il vescovo Claudio – del patrimonio spirituale, teologico e pastorale che la Chiesa di Padova ha costruito nei lunghi tempi dal dopo Concilio a oggi». Prima di lui, infatti, fu don Renato Marangoni a Belluno-Feltre nel 2016; cinque anni dopo don Giampaolo Dianin nella Diocesi di Chioggia; don Giuseppe Alberti nel 2023 come vescovo di Oppido Mamertina-Palmi e don Lucio Nicoletto a Sao Felix in Brasile nel 2024. Figli della Chiesa di Padova sono anche Marco Tasca, conventuale, nominato da papa Francesco arcivescovo metropolita di Genova nel 2020 e Christian Carlassare, comboniano, vescovo in Sud Sudan dal 2021. «La sua parola, i gesti e più ancora la sua umanità, il modo con cui lui ha inteso svolgere il ministero da vescovo di Roma come si è presentato con questo sguardo di attenzione – ricorda Renato Marangoni, nominato vescovo il 10 febbraio 2016 – Anche se le sue parole potevano essere “ripetitive”, nel senso che evidentemente il suo messaggio era quello e lui ce lo ricordava sempre, non erano solo parole ma era qualcosa di più, il suo stile, il suo modo di esserci, il suo sguardo. Io sono rimasto sempre colpitissimo di quel volto pastoso, solare e ti guardava e non necessariamente parlava, non chiacchierava, magari diceva anche qualche battuta, ma ti comunicava molto con la sua affabilità. Questo resta e penso che bisogna essere affabili per andarne fuori da certe logiche che sono di contrapposizione, di sconforto, di scontentezza, di arrabbiatura. Tante guerre sono la rabbia che c’è depositata dentro un’umanità fragilissima». Nel suo ultimo messaggio rivolto ai fedeli, affidato alla voce di mons. Diego Ravelli, ha invocato ancora una volta la pace, ricordando i tanti conflitti che affliggono il mondo, Palestina, Israele, Yemen e la «martoriata» Ucraina: «Anche questo aggettivo che lui sempre abbinava alla situazione dell’Ucraina “martoriata” a me ha sempre fatto riflettere – aggiunge Marangoni – È sempre stato su quell’aggettivo, ogni volta che nominava l’Ucraina: vuol dire che lui aveva la sensazione, una motivata percezione e conoscenza che la situazione di fatto era ingiusta. Penso che lui avesse tutte le ragioni per dirlo e per ripeterlo anche nei momenti in cui c’è stato a volte qualche incomprensione su qualche sua espressione. Questa costanza, questo permanere su quell’aggettivo ha detto un po’ la visione quella più profonda su questa situazione e che vale per tutti. Io ho l’impressione che lui l’avesse portata come emblematica: questo succede se ci sono certe logiche». Durante l’Urbi et Orbi nel giorno di Pasqua, papa Francesco aveva chiesto anche pace e conforto alle popolazioni africane vittime di violenze e conflitti, senza che su di esse si spenga la luce, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, in Sudan e Sud Sudan. Proprio da qui arriva il ricordo, emozionato, di padre Christian Carlassare, missionario comboniano originario di Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza e Diocesi di Padova, oggi vescovo di Bentiu, ma nominato proprio dal pontefice argentino l’8 marzo 2021 vescovo di Rumbek: «Il suo sguardo si è anche posato su di me per chiedermi prima di servire la Diocesi di Rumbek, e ora la nuova Diocesi di Bentiu. Nei giorni dell’attentato si è fatto presente con la sua preghiera. Questa sua attenzione nei miei confronti mi ha fortificato in vista del recupero dell’uso delle gambe e confermato nella volontà di tornare per essere testimone di pace e riconciliazione». Era da poco arrivato nella Diocesi di Rumbek, quando venne aggredito in casa di notte: gli spararono alcuni colpi di pistola alle gambe, dovette subire un intervento e un lungo periodo di riabilitazione prima di tornare a camminare. Al Sir, ricorda: «In un incontro mi ha chiesto se avessi paura di ritornare. Gli risposi che l’unica paura sarebbe stata quella di non essere in grado di servire la gente di Rumbek e del Sud Sudan perché il loro bisogno è grande. E lui, da padre buono, mi ha semplicemente detto: “Sappi che c’è il Signore. Non sei tanto tu. È lui che guida la sua Chiesa. Tu solamente testimonia la sua Parola”. Mi è stato di grande conforto e illuminazione. Fin dall’inizio del suo pontificato si è preso a cuore la situazione del Sud Sudan, come anche quelle di molte altre periferie umane. Nel silenzio che avvolge queste realtà, perché contano relativamente ai fini del potere e del mercato, lui ha prestato orecchio e se ne è fatto voce, sia nella preghiera che nel ricordo nei suoi Angelus, sia nell’invito a Roma dei capi politici del Sud Sudan che nella visita avvenuta nel 2023 come pellegrinaggio ecumenico di pace. Non lo dimenticheremo papa Francesco, anzi, forse lo incontreremo un po’ più avanti nel cammino, dove lui già sta in compagnia del Maestro». Un esempio di amore fraterno, di dialogo, di attenzione per le persone più vulnerabili e i gruppi più emarginati, riconoscendoci tutti fratelli e sorelle, figli dello stesso Padre. È in quest’immagine del Santo Padre che si affida il pensiero di mons. Giuseppe Alberti, nominato il 21 settembre 2023 vescovo di Oppido Mamertina-Palmi: «La sua testimonianza evangelica, fatta di una parola schietta, piena di “parresia”, e soprattutto con i suoi gesti di prossimità, in specie verso i più poveri, gli immigrati, quelli che meno contano, gli “scartati” della nostra società, ha scosso noi cristiani e anche molti uomini e donne di buona volontà». Tante espressioni figlie del suo vissuto, ma che nascono dalla sua profonda spiritualità e dalla convinzione che la Chiesa non può che essere missionaria: «Non dimentichiamo la sua vicinanza ai malati o le sue visite nelle carceri – rievoca Lucio Nicoletto – La preghiera del 27 marzo 2020, nei giorni bui della pandemia, in quella piazza San Pietro vuota, con il suono delle sirene delle ambulanze in sottofondo e l’impegno per la pace, la fraternità e lo sviluppo umano integrale. Oppure la cura che ha sempre avuto per la nostra casa comune, coinvolgendo altre Chiese e confessioni cristiane, altre religioni e leader mondiali, credenti e non credenti. Non dimentichiamo i suoi numerosi viaggi apostolici, rivolti alle periferie e alla riconciliazione, i suoi gesti di accoglienza della vita nuova, la benedizione delle donne incinte, il tempo dedicato all’ascolto delle vittime di abusi sessuali e tutto ciò che ha fatto per sradicare questa piaga dalla vita della Chiesa e della società». Tra le tante fotografie di questi 12 anni di pontificato, il vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin “estrae” il «semplice e familiare “buonasera” del primo giorno e quel suo inchinarsi chiedendo la benedizione dei fedeli» o la «prima uscita a Lampedusa, simbolo di un pontificato che ha messo i poveri al primo posto, tutti i poveri di ogni povertà». E i suoi documenti che rimarranno come pietra miliare di questo pontificato: «Sono testi che hanno avuto grande eco nella Chiesa e anche fuori della Chiesa. Ci lascia un testamento importante che non vogliamo lasciare ai libri di storia. Papa Francesco è stato anche una pietra d’inciampo e una presenza destabilizzante in nome del Vangelo che, se preso sul serio, continua a inquietare, provocare e anche scandalizzare. Papa Francesco ha scritto una pagina di Vangelo anche per come ha vissuto e ha comunicato: ha scelto di vivere a casa Santa Marta per essere vicino a tutti i suoi collaboratori, di vestire in modo sobrio e senza sfarzi, di andare a comprarsi gli occhiali come fanno tutti. Il suo linguaggio è stato sempre immediato, pieno di immagini e di sfumature che si imprimono nella memoria anche se non hanno il crisma di ciò che è ecclesialmente corretto. L’ultimo scritto di papa Francesco, firmato per il libro del cardinale Angelo Scola sulla vecchiaia, illumina questo momento raccontando come lui lo stava vivendo: “La morte non è la fine di tutto, ma l’inizio di qualcosa. È un nuovo inizio, perché la vita eterna, che chi ama già sperimenta sulla terra dentro le occupazioni di ogni giorno, è iniziare qualcosa che non finirà. Ed è proprio per questo motivo che è un inizio nuovo, perché vivremo qualcosa che mai abbiamo vissuto pienamente: l’eternità”».