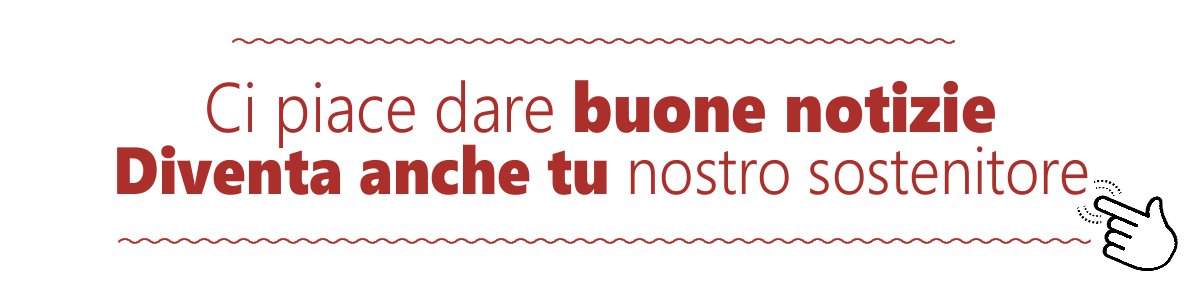L’ideale di Giacomo Prandina
Konzentrationslager Gusen. Già solo a leggerlo mette i brividi. Il campo di concentramento di Gusen è stato un lager della Germania nazista; vi erano collocati tre dei 49 sottocampi di Mauthausen.

Dal dicembre del 1939 gli internati del campo principale vennero costretti a realizzare questa “succursale”, che nel maggio 1940 accolse i primi deportati (polacchi e spagnoli), obbligati a lavorare nelle cave di granito. Poi sarebbero arrivati anche francesi, sovietici, jugoslavi e italiani. Nel 1943 due grandi aziende tedesche (la Steyr-Daimler-Puch Ag, che produceva fucili, e la Messerschmitt GmbH, che realizzava aerei da caccia) trasferirono a Gusen parte della loro produzione. Nel marzo 1944 si iniziò a realizzare un ampliamento del campo, il Gusen II. Le condizioni di vita erano assolutamente disumane: almeno 8.600 prigionieri furono assassinati o morirono a causa dei ritmi serrati di lavoro. Fino alla liberazione, avvenuta a opera dell’esercito statunitense il 5 maggio 1945, a Gusen vennero incarcerati 71 mila prigionieri, provenienti da 30 Paesi. Più della metà non sopravvisse. Ottant’anni fa, il 13 marzo 1945, proprio a Gusen trovò la morte, a soli 27 anni, anche il partigiano cattolico Giacomo Prandina, al cui nome è legata un’ex caserma di Padova, che il Comune ha acquistato nel 2021 per realizzarvi il Parco delle Mura di San Benedetto (a tal proposito, il vicesindaco Andrea Micalizzi, alfiere del Partito democratico, ha garantito, dopo le proteste dell’Anpi e del Comitato urbanistico e contesto, che il nome di Prandina non verrà dimenticato). Ma chi era Prandina? Ingegnere, militare e partigiano, decorato di medaglia d’oro al valor militare, era nato a San Pietro in Gu il 25 luglio 1917 (solennità di San Giacomo). Era l’ultimo di undici fratelli: dopo quattro femmine (Maria Maddalena, Anna, Maria Santa e Maria Caterina) erano nati cinque maschi (Antonio, Bortolo, Angelo, Pio, Luigi). Poi ancora una femmina, Giulia, che si era fatta suora come Maria Santa. Suo padre, guadense, classe 1874, era un contadino non possidente e aveva un nome di battesimo davvero inconsueto (Opprandino); la madre, originaria di Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza, si chiamava Adelaide Lovato ed era nata nel febbraio 1876. Giacomo frequentò le elementari nel suo paese. Fin da ragazzino frequentò l’oratorio e il circolo della Gioventù italiana di Azione cattolica; parroco di San Pietro in Gu era l’arciprete mons. Bortolo Castegnero. Poi si iscrisse alle scuole parrocchiali di Sandrigo, dove conobbe mons. Giuseppe Arena, che si opponeva alle violenze dello squadrismo fascista. Frequentò il ginnasio e il liceo classico nel seminario di Vicenza; il 21 luglio 1936 conseguì, da privatista, la maturità classica con ottimi voti al liceo berico Pigafetta. Suo padre era mancato tre anni prima, nell’aprile del 1933. Nel novembre 1936 Giacomo, che era domiciliato presso il collegio Barbarigo, in via Rogati 11 a Padova, s’iscrisse al corso di laurea in matematica e fisica della facoltà di Scienze. Il 23 giugno 1941 il rettore Carlo Anti gli conferì la laurea in ingegneria industriale elettrotecnica con la votazione di 100/100. Nel frattempo lo studente modello partecipava anche alle attività della Federazione universitaria cattolica italiana. Alla fine del 1941 Prandina si iscrisse al corso di specializzazione in ingegneria aeronautica al Politecnico di Torino e nel 1943 frequentò la Scuola per allievi ufficiali del Genio aeronautico, da cui uscì con il grado di sottotenente di complemento e subito entrò alla Fiat come collaudatore aeronautico. Dopo l’armistizio di Cassibile, lasciò il comando della Regione aerea di Padova e raggiunse per qualche giorno la famiglia, prima di aderire alla Resistenza, dove si occupò in particolare dell’allestimento dei campi di aviolancio. Dal 4 febbraio al 30 settembre 1944 fu vicecomandante provinciale della brigata Cesare Battisti della divisione Vicenza e poi, con il nome di battaglia di “Pierre”, commissario del comando provinciale dal 1° al 31 ottobre 1944. A San Pietro in Gu, dove si era recato per assistere la madre malata, venne arrestato dai militi della Guardia nazionale repubblicana, il corpo di polizia della Repubblica di Salò. Dopo 53 giorni nelle carceri di San Biagio a Vicenza, Prandina venne trasferito a Bolzano e qualche giorno prima di Natale, fu deportato su un camion a Mauthausen, dove arrivò l’11 gennaio 1945. Il 16 febbraio fu inviato nel sottocampo di Gusen per essere utilizzato nel Dest (Deutsche Erd-und Steinwerke GmbH, società della SS che produce materiale edile) nel settore della produzione di aeromobili a St. Georgen-Bergkristall. Giacomo Prandina però riuscì a resistere solo fino al 13 marzo 1945, poche settimane prima dell’arrivo degli americani. Come scritto, non aveva ancora 28 anni. Sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 3 agosto 1949 è stato pubblicato il decreto che attribuisce a Prandina la medaglia d’oro al valor militare. Questa la motivazione: «Di casa in casa, di paese in paese, ancora ricordato con commosso pensiero da quanti ascoltarono la sua parola, fu apostolo di fede che insegnò ai giovani e scosse i dubbiosi. Le prime squadre partigiane dell’Alto Padovano e del Vicentino furono da lui amorosamente curate e potenziate, i primi campi di aviolancio da lui impiantati; i primi servizi di raccolta notizie da lui organizzati. Uomo di azione partecipò a centinaia di atti di sabotaggio, emergendo per ardire e sprezzo del pericolo. Arrestato, subì disumane torture che, se piagarono il suo corpo, ne rafforzarono l’anima. Mantenne spirituali rapporti con i compagni di fede che non volle spendessero per salvarlo energie e forze da riservare solo alla lotta per la Patria oppressa. Portato in Germania e rinchiuso in campo di annientamento, soccombette alla fame, agli stenti e alla pena che fino alla morte consumò il suo cuore in un’ardente fiamma di amore per la Patria lontana». Tornando al campo di concentramento di Gusen, va detto che solo nel 1965, dopo che buona parte del campo era stato rimosso (eliminata la recinzione; sui terreni sono stati realizzati edifici residenziali), le organizzazioni internazionali dei deportati sono riuscite, a loro spese, a realizzare un memoriale attorno a quello che era stato il forno crematorio. Il progetto porta la firma dell’architetto Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1909-2004), che fu prigioniero a Gusen e che alla fine della guerra riuscì a tornare a Milano. Per sua disposizione l’architetto è stato sepolto con il fazzoletto dell’Aned (Associazione nazionale ex deportati campi nazisti), caratterizzato dal triangolo rosso, in memoria delle vittime dell’olocausto. Dal 1997 il monumento (in tedesco noto come KZ-Gedenkstätte) è stato affidato alla competenza della Repubblica austriaca.
D’inciampo
Oltre all’ex caserma diventata parcheggio a Padova, alla memoria di Giacomo Prandina è intitolata una via nel quartiere Mortise: da via Guido Cardan la seconda a destra. È ricordato anche dalla toponomastica di Grantorto; di Vicenza (nella via Prandina ha sede la chiesa di Sant’Antonio ai Ferrovieri); di Carmignano di Brenta. Al giovane partigiano trucidato a Gusen ha dedicato la piazza del municipio il suo Comune natale, San Pietro in Gu, dov’è vicesindaco una nipote di Giacomo, Lorenza Prandina. L’amministrazione, il 20 aprile dell’anno passato, per iniziativa dell’Istituto storico della Resistenza di Vicenza, ha anche omaggiato la memoria di Giacomo Prandina con una pietra d’inciampo.
Mariano Rumor e l’amicizia con Giacomo Prandina
Presidente del Consiglio dal 13 dicembre 1968 al 6 agosto 1970, poi dall’8 luglio 1973 al 23 novembre 1974, più volte ministro e segretario della Democrazia cristiana, al vicentino Mariano Rumor, il 30 agosto 2020, nel trentesimo anniversario della morte, il Comune di Tonezza del Cimone ha dedicato la piazza centrale del paese. Nella targa si fa memoria dell’appartenenza giovanile di Rumor all’Ac e si ricorda l’amicizia che lo legava a Giacomo Prandina, uno dei tanti “giovani ribelli per amore”, che hanno sacrificato la loro vita per liberare l’Italia dall’occupazione nazifascista.