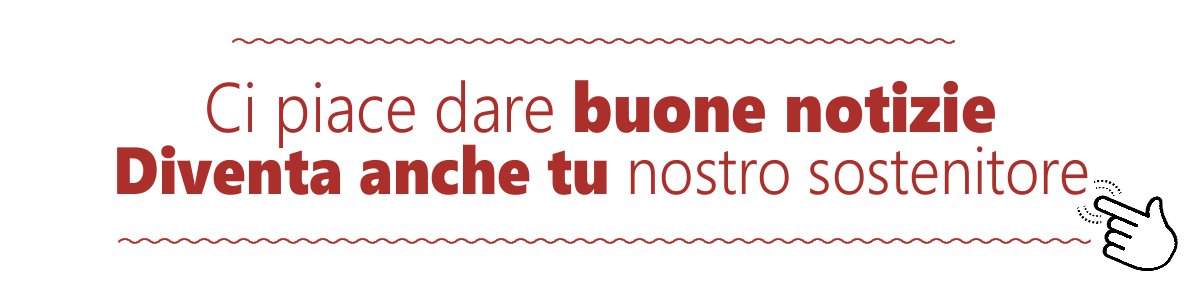Il Figlio attende la Madre in cielo. Nella chiesetta dei Penitenti a Piove di Sacco la Dormitio Virginis
San Pietro celebra il funerale della Vergine, la cui anima è già assunta in cielo tra le braccia di Cristo. Tra apostoli e angeli compare anche la figura di san Paolo. Nella chiesetta dei Penitenti a Piove di Sacco si trova un trecentesco affresco che raffigura la Dormitio Virginis, ovvero il momento del trapasso di Maria

Le opere d’arte molto spesso raccontano più di quello che sembra: fa parte del loro fascino. Per questo è utile soffermarsi a osservare qualche particolare, a leggerne la storia, anche per quelle meno note. Come nel caso di un affresco, sconosciuto ai più, che si trova nella cosiddetta “Chiesuola”, nomignolo decisamente poco appropriato con cui è nota la chiesetta di Santa Maria dei Penitenti, attigua al maestoso Duomo di San Martino di Tours, a Piove di Sacco. Il dipinto in questione è quello della Dormitio Virginis, ovvero la rappresentazione di Maria nel letto di morte: qualcosa che non è narrato nelle Sacre Scritture, ma si trova in vari antichi scritti apocrifi. Non se ne conosce l’autore, ma l’opera, come scriveva Francesca Flores d’Arcais, «è caratterizzata da un gusto popolareggiante privo di caratteri gotici e va ascritto a un artista della cerchia del Giotto padovano, con influssi riminesi». La data di realizzazione è posteriore all’edificazione della chiesetta, ovvero il quarto decennio del Trecento. L’iconografia del momento del trapasso della Vergine, distesa sul letto e attorniata dagli apostoli, è di ispirazione bizantina ed è, per quel tempo, l’immagine più comunemente usata per illustrare la scena, visto che non è ancora stato proclamato il dogma dell’Assunzione, oltre che dell’anima, anche del corpo di Maria, benché già nel tardo Medioevo fosse diffuso il pensiero che esso, in quanto appartenente alla Madre di Dio, non aveva potuto subire la corruzione del sepolcro. Un dogma poi proclamato solo nel 1950, quando da tempo la storia dell’arte aveva riempito le chiese delle immagini festanti e gloriose dell’Assunzione, come quella celeberrima del Tiziano ai Frari di Venezia (1518): immagini di certo ispirate anche alla splendente «donna vestita di sole» che compare nell’Apocalisse di san Giovanni. Oltre alla data, l’altra verosimile certezza è che questo affresco sia stato eseguito proprio per questa chiesa, che un tempo non era per nulla piccola come il nomignolo “chiesuola” farebbe pensare. «Si tratta invece della più antica chiesa di Piove di Sacco – racconta Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova e del Museo Paradiso del Duomo saccense – che fu edificata dopo il 1334 ma su preesistenze risalenti al 9° secolo. Era più lunga, si estendeva verso la torre civica che funge anche da campanile». Dopo la costruzione del Duomo la chiesa perse di importanza, e nel corso del Novecento fu a più riprese rimaneggiata, accorciata e ribassata. «È possibile – continua Nante – che il dipinto della Dormitio Virginis fosse parte di un più ampio ciclo di affreschi sulla vita di Maria, andato perduto, ma purtroppo non vi sono testimonianze in merito. È arrivato a noi conservato all’interno di una cornice lignea che rinvia a una bottega veneta del Seicento, quindi non la sua originale, e si è salvato dai ripetuti rimaneggiamenti dell’oratorio perché probabilmente aveva trovato una collocazione come pala d’altare». Quanto all’autore, non vi è dubbio alcuno sull’ispirazione giottesca: vi sono rimandi, ad esempio, al dipinto di analogo tema, sempre di autore ignoto, nella Cappella degli Scrovegni, o a quello di Giotto oggi conservato a Berlino, come le espressioni dei volti e la disposizione delle figure, alcune davanti al feretro e persino di spalle. Poiché l’opera si trova a Piove di Sacco, sarebbe affascinante pensare alla mano di un giovane Guariento, che del luogo era nativo, ma è un’ipotesi che gli studiosi non hanno preso in considerazione anche per motivi cronologici. Molti sono i particolari su cui varrebbe la pena soffermarsi, tra tutti si può segnalare quel clima di intima tenerezza che, nell’iconografia che si affermerà nei secoli successivi, ovvero quella dell’Assunzione di Maria in gloria tra angeli e santi, un po’ si viene a perdere. Ne è di esempio il suggestivo brano in cui si vede Gesù che, all’interno di una mandorla di bizantina memoria, non solo accoglie, ma addirittura abbraccia, l’anima della madre appena salita al cielo dopo avere abbandonato il suo corpo mortale, «totalmente ricoperta dell’azzurro del Mistero» (come ricorda Roberto Filippetti nel suo volume Raccontare l’avvenimento). Come non ricordare quel verso del 23° canto del Paradiso dantesco, vergato solo pochi anni prima della realizzazione dell’affresco, che recita: «Vergine madre, figlia del tuo figlio…»? Tra gli apostoli raccolti in preghiera attorno al corpo esanime di Maria – stranamente solo uomini e angeli, nessuna donna – c’è Mattia, subentrato ormai a Giuda, e si riconosce anche la figura di san Paolo, collocata in posizione opposta a quella di san Pietro, che celebra invece il funerale. «Trovo molto bello anche il particolare dell’angelo – conclude Nante – con la guancia gonfia perché sta soffiando sul turibolo per diffondere l’incenso, come se accompagnasse così il viaggio dell’anima santa verso Dio». Oggi la chiesetta è oratorio dedicato all’adorazione perpetua (8-19 dal lunedì al venerdì). Alla domenica è accessibile dalla sacrestia del Duomo, come parte del percorso di visita, guidato da volontari, del Museo Paradiso.
Un museo che è un Paradiso
Il duomo di Piove di Sacco ospita opere di grande interesse, tra cui due tele del Tiepolo: la prima, la pala della Madonna del Carmine, è collocata in chiesa; l’altra, che raffigura San Francesco di Paola, si trova nella sala sopra la sacrestia che, dal 2017, è adibita a museo. Il nome, Paradiso, è mutuato dall’antico oratorio che si trovava proprio dove ora c’è la sacrestia e, prima ancora, un’area cimiteriale. Aperto la domenica, raccoglie opere da varie chiese locali tra cui un polittico di Paolo Veneziano.
Storia dell’arte. L’iconografia dalla Dormitio all’Assunzione
Nella Sacra Scrittura nulla si dice della morte e dell’assunzione al cielo, in corpo e anima, di Maria. Da dove arriva quindi l’iconografia che tante volte vediamo in affreschi e dipinti? «A questa reale mancanza suppliscono alcuni testi apocrifi – rivela mons. Pasquale Iacobone, presidente della Pontificia commissione di archeologica sacra – quasi tutti noti con il titolo di Transitus beatae Virginis, che ebbero una incredibile diffusione. In Europa quest’insieme di racconti trova popolare formulazione nella Legenda aurea di Jacopo da Varagine e nello Speculum Historiale di Vincenzo di Beauvais: sono questi i testi che artisti e committenti consultano per trarne ispirazione». Ma cosa raccontano questi testi? Vi si narra la visita di un angelo a Maria per annunciarle la morte imminente, il dono di una palma del Paradiso per il funerale e l’arrivo miracoloso di tutti gli apostoli presso di lei. Maria muore col sorriso per il sopraggiungere del Figlio, che accoglie la sua anima. Il corpo viene affidato a Pietro per la sepoltura: il sommo sacerdote tenta di rovesciare il lettuccio con la salma, ma le mani gli rimangono incollate finché non confessa la fede in Cristo. Dopo tre giorni lo stesso Cristo, circondato da miriadi di angeli, fa innalzare il corpo di Maria sulle nubi e lo trasporta in Paradiso, a ricongiungersi con la sua anima. «Le prime immagini dell’Assunzione della Vergine nell’Occidente latino risalgono all’8°-9° secolo – continua mons. Iacobone – e ricalcano l’iconografia dell’Ascensione di Cristo: Maria appare in un tondo trasportata in cielo dagli angeli. In Oriente si impone invece la tipologia della Dormitio o Kóimesis, in cui Maria viene rappresentata nel letto di morte, circondata dagli apostoli mentre Cristo regge la sua animula: è un’immagine che si ritrova anche in Occidente dopo l’anno Mille, sempre più spesso riproposta con varianti desunte dagli apocrifi e dai due testi citati, più narrativa e favolistica, dove si assiste a una sorta di contaminazione tra le due tipologie, come nell’affresco di Cimabue per la basilica superiore di san Francesco, ad Assisi, e in quello di Piove di Sacco». Nel Rinascimento la scena si concentra sempre più sulla tomba vuota, attorniata dagli apostoli colti da stupore, e sulla figura di Maria portata in cielo sulle nubi attorniata da angeli musicanti. Il grande esempio è l’Assunta di Tiziano nella chiesa dei Frari di Venezia (1518). «Due tradizioni iconografiche – conclude mons. Iacobone – si confrontano e si fondono per dare vita a numerose rappresentazioni, ognuna con i suoi tratti originali. Nelle opere d’arte si attua pertanto, attraverso il genio degli artisti, una straordinaria sintesi di testi liturgici e apocrifi, patristici e medioevali, senza dimenticare l’agiografia e la narrativa popolare e la spiritualità mariana che alimenta nuove forme devozionali e espressioni artistiche».
Dagli apocrifi alla narrazione popolare
Le origini della festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria sono oscure, si mescolano nei secoli con la celebrazione della sola Dormitio Virginis. La tradizione dei monaci di Palestina del 5° secolo la pone al 15 agosto, data adottata dall’impero bizantino e poi in Occidente. I testi apocrifi narrano con dovizia di particolari spesso fantastici questo evento che nel Nuovo Testamento non è descritto: sono narrazioni che ebbero però grande diffusione.