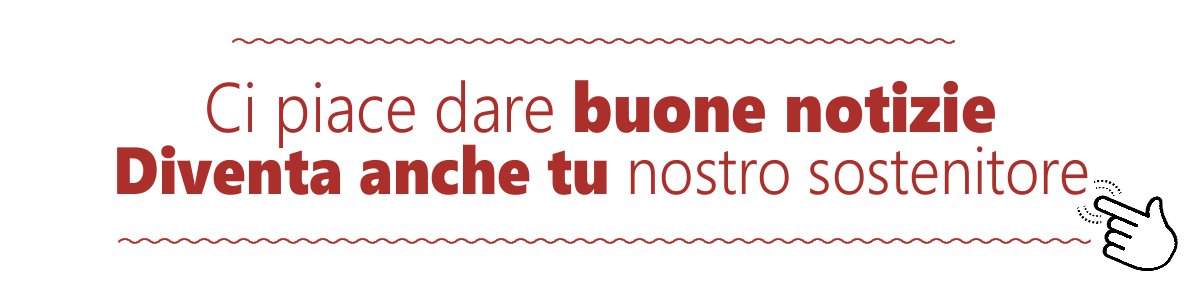Punire o ricostruire? Il percorso della società dopo la sentenza Turetta secondo padre Guido Bertagna
Esiste altro oltre alla “reazione primaria”: ci sono orizzonti di lettura che fanno di una sentenza non un punto di arrivo, ma un cammino collettivo

Tre proiettili in un busta, indirizzata all’avvocato Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta. Ma anche reazioni “di pancia”, che viaggiano sui social e che vorrebbero un “fine pena mai” perché «tanto Giulia non ritorna in vita». C’è una sentenza, ergastolo, ma sembra insufficiente. Perché si arriva a tanto? «Da una parte mi sembra che ci sia una dimensione che si può chiamare di “reazione primaria”, molto emotiva e questo è più facile che avvenga anche a livello di folla, di opinione pubblica che reagisce con la veemenza rispetto alla gravità e al modo con cui questa gravità impatta sul vissuto – spiega padre Guido Bertagna, gesuita che da anni si occupa di giustizia riparativa – Ma va capito e accolto, credo, anche se pesante, anche se suscita dolore, e domande sulla consapevolezza che abbiamo come società civile. È una parte di società che, un po’ troppo affannosamente, cerca un criterio per dire “così non va”, “così non può essere”, “le relazioni non si vivono così”, “non si può reagire con una violenza di questo genere”. Poi c’è un secondo livello, e qui comincia a esserci un po’ di fragilità sia nell’opinione pubblica sia da parte delle persone che potrebbero aiutare la riflessione, incluso l’ambiente ecclesiale, in cui si rischia tutti di rimanere imprigionati da questa reazione primaria, cioè di non riuscire ad accedere a un altro orizzonte di lettura, per esempio l’orizzonte che ci fa dire “questo male ci riguarda” o che non è soltanto degli altri o di quello che oggi è additato come persona da rifiutare. No, questo male ci appartiene. Da questa consapevolezza che attinge innanzitutto alla consapevolezza di essere umani quali siamo in cui abita lo slancio d’amore e anche la forza di risposte violente, allora da qui, da questa presa di coscienza si può comunicare qualcosa di più serio, che rifugge dall’illusione – perché di tale si tratta – che buttare la chiave sia la soluzione per allontanare il male. Il male ce lo portiamo dentro».
Lei parla di orizzonti di lettura, papà Gino Cecchettin, con il suo esempio, ce ne ha offerto uno, lontano da qualsivoglia forma di rabbia. Se un papà, direttamente coinvolto, ci consegna quest’opportunità perché non seguirlo?
«La fatica ad accedere a quel livello lì, a quell’orizzonte di lettura che papà Gino ci ha offerto, è proprio per il fatto che questo orizzonte impegna: è molto più facile proiettare e mettere su altri tutta la violenza e il peggio e pensare di chiamarci fuori. Mi sembrano interessanti le parole, su cui si potrà da ora e per il futuro costruire qualcosa, pronunciate da Gino Cecchettin, nel commentare la sentenza: “Abbiamo perso tutti”. Se abbiamo perso tutti vuol dire che siamo tutti chiamati a contribuire a queste riflessioni. Che cosa abbiamo perso? Che cosa ci siamo persi? Sono delle parole che possono illuminare, un percorso che comunque è impegnativo anche come Chiesa».
A oggi, Filippo Turetta non ha mostrato pentimento, per quello che carte, processi e deposizioni ci consegnano. Dall’altro lato abbiamo un ordinamento giustamente riabilitativo e rieducativo, che ragiona anche in temi riparativi. Come possono collimare?
«C’è una prima necessaria distinzione da fare, a livello di linguaggio usato, dal parlare comune ai media: tendiamo a usare come sinonimi la parola colpevole e la parola responsabile. Una persona dichiaratamente reo confesso di un fatto è colpevole di questo ed è chiamato a risponderne. Però diventarne responsabile, essere capace di assumersi il male che ha commesso, elaborarlo, collocarlo in un percorso previsto come dall’articolo 27 della Costituzione, un percorso riabilitativo e reintegrativo nella società civile, ecco questo non è automatico. Quindi è fuorviante usare come sinonimi colpevole e responsabile perché una persona colpevole non è detto che sia immediatamente capace di rispondere pienamente, dipende dal cammino che si fa, da chi lo aiuta in questo cammino, dipende se lui si lascia aiutare. In questo senso, il tempo della pena – l’ergastolo – lunghissimo è anche un tempo che offre un’opportunità, ma non è un’opportunità magica, non è che il tempo da solo “è buon medico”. Il tempo può diventare opportunità se diventa occasione per incontrare, per ripensare dolorosamente a quello di cui ci è resi come autori. Da questo punto di vista non è pensabile valutare il vissuto interiore di una persona, come di questo giovane, sulla base di quello che lui ha mostrato all’esterno adesso: è molto pericoloso valutare con criteri che sono proiettivi nostri, sulla base di quello che ci immaginiamo. Sarebbe tutto troppo schematico».
Noi come media, ma anche organi educativi come Chiesa, famiglie, scuole, di quali “anticorpi” possiamo disporre per arrivare serenamente a quell’impegno di lettura che, per esempio Gino Cecchettin, ha raggiunto prima di noi? Cosa possiamo consegnare a chi vorrebbe aprirsi verso un orizzonte che vada oltre la reazione primaria?
«Si possono sostenere quei percorsi di giustizia che vanno a lavorare sulle ferite che un male, un reato lascia nelle persone direttamente coinvolte e nella società tutta. Anche per la risonanza, questo delitto ha ferito il Paese intero. Si può costruire un percorso che vada a lavorare non tanto sull’aspetto di punizione esemplare, per altro tutta rivolta al passato: è una giustizia rivolta a punire il fatto con un male “corrispondente” e chiediamo a un doppio male – quello di Filippo inflitto a Giulia e il male che stiamo infliggendo a lui, sia pure un male proporzionato, disciplinato dallo stato di diritto – di generare un bene. Ma accedere a questo modo di pensare significa mettersi in gioco: prendiamo le parole di Gino, che significa che abbiamo perso? Quindi dobbiamo costruire una giustizia che lavori sulle relazioni, che restituisca la parola al dolore, che permetta laddove possibile spazi di inconto, spazi seri di rivisitazione di quanto accaduto, se lo stesso autore si renderà disponibile a un percorso del genere, ma non gli può essere chiesto adesso in maniera quasi meccanica in rapporto a quello che la sentenza ha stabilito. Non dobbiamo prenderlo come punto di arrivo: è un cammino che riguarda tutti, se è vero che tutti ci abbiamo perso».