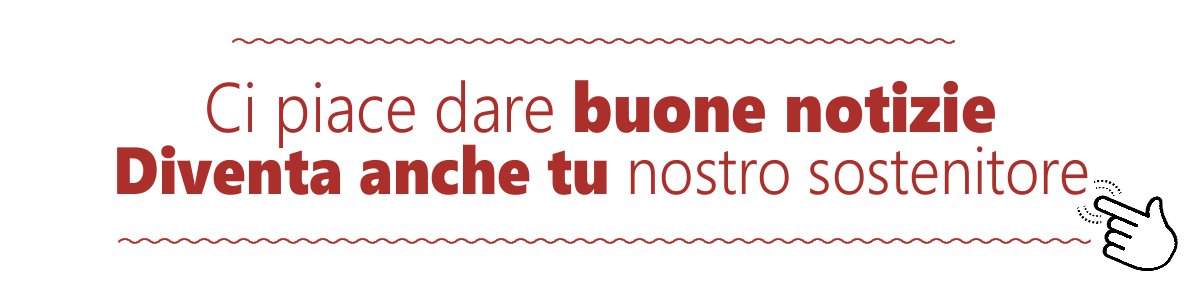La persona non è il suo reato. Gian Luigi Gatta sulla sentenza a carico di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin
La sentenza a carico di Filippo Turetta ha spaccato l’opinione pubblica. Gatta: «La nostra Costituzione riconosce il valore della persona anche se autrice di atti efferati»

Martedì 3 dicembre la Corte d’Assise di Venezia ha emesso la sentenza di ergastolo a carico di Filippo Turetta, l’ex fidanzato che ha confessato il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a Fossò (Ve) l’11 novembre 2023 e ritrovata otto giorni dopo a Barcis. La sentenza ha scatenato nell’opinione pubblica un marcato malcontento perché non sono state riconosciute le aggravanti dello stalking e della crudeltà e perché, nonostante la gravità della pena, tra otto anni il condannato potrebbe iniziare a godere di permessi premio.
Gian Luigi Gatta, professore ordinario di Diritto Penale all’Università degli Studi di Milano, come valuta questa situazione?
«Le rispondo con una domanda: dove può portare il malcontento non per un’assoluzione o per una condanna “lieve”, ma per una condanna all’ergastolo, cioè alla più grave tra le pene? Il rischio è di fare passi indietro nel percorso di umanizzazione della pena, regredendo verso il linciaggio, la pena di morte o l’ergastolo a vita, con le chiavi della cella buttate via. Non dovremmo forse prendere atto che una Corte composta anche da giudici popolari ha inflitto la pena più grave, e che le ulteriori aggravanti (crudeltà e stalking) non avrebbero comunque potuto rendere più grave quella massima pena?
Perché nel nostro ordinamento giuridico una persona condannata all’ergastolo può avere delle esperienze fuori dal carcere e vedere la pena concludersi dopo ventuno anni?
«La nostra Costituzione riconosce il valore della vita e della persona, anche quando si tratta dell’autore di un gravissimo reato. Una persona non coincide col reato che ha commesso: è molto di più della cosa peggiore che ha fatto e può, deve, essere avviata a percorso di recupero, riconciliazione e, nei limiti del possibile, di riparazione. Ecco perché è vietata la pena di morte. Ecco perché è vietato buttare le chiavi della cella. Ecco perché, invece, ancor più quando si tratta di giovani, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, con le parole dell’articolo 27 della Costituzione. Non è affatto detto che l’ergastolano esca dal carcere dopo otto anni, grazie a permessi premio, e ottenga la liberazione condizionale dopo 21 anni. Non c’è nessun automatismo. Accadrà solo se e quando il detenuto avrà compiuto progressi sulla via del recupero e servirà, se ci saranno le condizioni, all’esito di un percorso personale di revisione critica dell’accaduto, per favorirne il suo reinserimento sociale. Nessuna impunità, nessuna indulgenza: solo la mano tesa verso un percorso di reinserimento e recupero alla società civile».
Come si è arrivati a scrivere norme che hanno stabilito questo percorso?
Qual è il loro valore dal suo punto di vista? «Ci si è arrivati rifiutando la pena di morte e valorizzando l’idea del recupero delle persone. Lo Stato non uccide l’omicida ma se ne prende carico in carcere, indicandogli un possibile percorso, che contempla oggi anche la possibilità dell’incontro con le vittime e i loro cari, nell’ambito della “giustizia riparativa”, per chiedere perdono e compiere gesti di riconciliazione con la società, riaffermando i valori violati. Realizzare tutto ciò è difficile e richiede molto tempo, personale esperto, formazione e investimenti, anche culturali. Dall’idea della vendetta si è passati all’idea del possibile recupero di chi ha commesso reati anche gravissimi, una volta espiata la pena. Una società che dà valore al perdono e all’espiazione è senz’altro più propensa alla pace sociale e alla riconciliazione e mette al centro il valore della persona. È una società migliore della violenza che combatte».
Sembra che, da tempo, nel Paese sia presente una concezione della pena intesa più come “vendetta” di Stato che come rieducazione. Come mai passi avanti in termini di civiltà non sono percepiti come tali? «Essere civili davanti all’inciviltà, di più, all’efferatezza di un femminicidio premeditato, non è per niente facile. La reazione istintiva che proviamo è di ripagare il male col male, secondo la legge del taglione. Il ruolo dello Stato è di sedare le reazioni istintive della società facendosi carico in modo razionale del problema causato dal reato e del suo autore. La responsabilità dei media e della politica è di non cedere alla tentazione di soffiare sul fuoco della rabbia sociale di fronte a femminicidi e crimini efferati; occorre invece lavorare a una giustizia che sappia prevenire, punire, riconciliare, riparare nei limiti del possibile e recuperare le persone al consesso civile. Senza buonismi, con effettività. Serve alla pace sociale e al progresso civile.
Dopo la sentenza, la sorella della vittima, Elena Cecchettin, ha commentato che si tratta della conferma che alle istituzioni non importa nulla delle donne. E ha sottolineato come una «verità giudiziaria» non tolga il dolore, la violenza fisica e psicologica che la vittima ha subito.
«Il dolore e la rabbia delle vittime vanno rispettati. È vero che la verità processuale ha dei limiti, che sono propri della giustizia terrena. Ed è evidente che una sentenza di condanna, anche all’ergastolo, può lasciare un senso di insoddisfazione e di ingiustizia a fronte di un’offesa così grave. Ciò significa che la punizione non è sufficiente. Ma non tanto perché ne servirebbe una più grave, bensì perché ci sono offese irreparabili. Nessuno può far tornare in vita una persona strappata alla gioia della vita e all’amore dei suoi cari. La condanna dell’autore non ripara. Il risarcimento pecuniario sembra persino offensivo. Può invece forse dare qualche sollievo qualcosa che sta oltre il processo e la pena e che solo il tempo può far maturare. Che si spengano allora i riflettori e si rispetti il dolore delle persone coinvolte, acuito dal processo, senza lasciarle mai sole».
Il prof. Giovanni Caruso, avvocato difensore di Filippo Turetta, è stato raggiunto da pesanti minacce di morte. Un fatto inquietante che segnala scarsa conoscenza del sistema giudiziario e intolleranza.
«Per la nostra Costituzione la difesa è un diritto inviolabile. Si tratta di una difesa tecnica, che va naturalmente garantita anche agli accusati di reati gravissimi. Il prof. Caruso ha svolto il suo ruolo di avvocato e ha fatto il suo dovere. La spettacolarizzazione della giustizia – il processo mediatico – comporta rischi evidenti. Le ragioni che hanno portato la Corte d’Assise ad escludere le aggravanti della crudeltà e dello stalking sono tecniche, non immediatamente comprensibili ai non addetti ai lavori. Le conosceremo quando saranno depositate le motivazioni della sentenza di condanna. Questa vicenda deve valere da avvertimento: il rischio paradossale è che chi condanna la violenza dell’assassino si renda autore di atti violenti; e che violenza generi violenza, proprio mentre ci impegniamo come società per prevenirla».