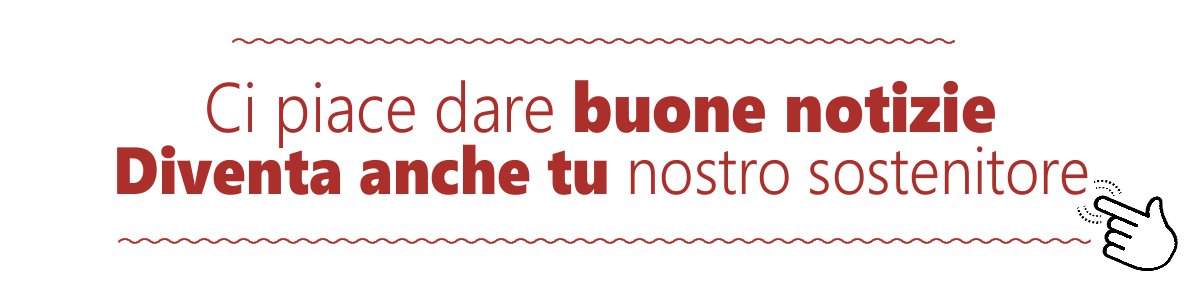Card. Pizzaballa: “La speranza non è una soluzione politica del conflitto, adesso è il tempo delle domande sul futuro”
“In Terra Santa non dobbiamo confondere la speranza con una soluzione politica del conflitto che non vedremo. La speranza non è uno slogan da urlare, ma un modo di vedere e di stare nella vita”. Come vivere da cristiani nel conflitto: ruota intorno a questo nodo l’intervista al Sir del card. Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, rilasciata in occasione di un incontro, ieri nella Città Santa, con un gruppo di pellegrini delle diocesi di Milano, Trento, Brescia, Tortona, Piacenza e Novara, guidati da Adriana Sigilli (Diomira Travel). Il pellegrinaggio ha come tema lo stesso del Giubileo 2025, “Pellegrini di speranza”

“In Terra Santa non dobbiamo cadere nella tentazione di confondere la speranza con una soluzione politica del conflitto che non vedremo, forse le generazioni dopo di noi. Sono, infatti, due cose diverse. La speranza non è uno slogan da urlare ma un modo di vedere e di stare nella vita”.
È la convinzione espressa dal patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, che ieri nella città santa ha salutato un gruppo di pellegrini, laici, religiosi e sacerdoti, provenienti dalle diocesi di Milano, Trento, Brescia, Tortona, Piacenza e Novara, guidati da Adriana Sigilli (Diomira Travel). Partito il 3 febbraio (fino al 7), il pellegrinaggio ha come tema lo stesso del Giubileo 2025, “Pellegrini di speranza” ed è stato proprio questo il filo rosso di tutto il dialogo tra il patriarca e i pellegrini. Per l’occasione, il Sir ha incontrato il card. Pizzaballa.
Eminenza, siamo nell’Anno Santo dedicato alla speranza. Come si può parlare di speranza in un Terra segnata da violenze e guerre?
La speranza non è uno slogan ma un modo di vedere e di stare nella vita. Quando incontro le persone è difficile parlare di speranza nel contesto attuale perché bisogna essere concreti. Siamo i figli dell’Incarnazione,
la fede deve poter dire qualcosa di concreto nella vita reale, non certo di astratto.
La speranza non può essere disgiunta dalla fede che ne è fondamento. E questo vale anche a livello laico. Un segno di speranza, poi, è la gente stessa che incontro; è vero, c’è tanto male, pensiamo solo alla violenza di questo ultimo anno e mezzo, ma c’è anche tanta gente che continua a dare la vita. Ci sono tanti giusti per i quali vale la pena continuare a impegnarsi. C’è un ulteriore segnale di speranza che non dobbiamo dimenticare…
Quale?
Sperare qui in Terra Santa significa anche tenere aperta la strada per il futuro, avere coscienza dell’altro così com’è e non come vorresti che sia. Come Chiesa abbiamo ‘vissuto’ la guerra fuori e dentro, ci sono modi diversi di vedere il conflitto.
In questa ultima guerra avevamo cristiani sia nell’esercito che tra la popolazione di Gaza. Non è stato semplice gestire questa diversità di opinione. Abbiamo usato un linguaggio chiaro, onesto e sincero ma che non chiudesse al dialogo e alle relazioni.
Non serve erigere barriere perché, in contesti come l’attuale, bisogna dialogare con tutti. Avere coscienza di questo senza essere rinunciatari.
La tregua a Gaza e in Libano sembra reggere ma come più volte lei ha ripetuto, la tregua non è la fine del conflitto. Cosa serve, allora, per far cessare questo conflitto e abbassare la tensione in Cisgiordania?
Abbiamo bisogno di una nuova visione e una nuova leadership. Non credo che si sia in condizioni, oggi, di avviare seri e costruttivi discorsi sul futuro. A breve termine qualcosa si deve certamente fare ma bisogna lavorare anche per il lungo periodo perché non credo che la fine del conflitto arriverà così presto.
E poi va chiarito cosa si vuole fare, dove si vuole arrivare e cosa si potrà concretamente fare. Discorsi che non si possono fare senza nuovi interlocutori.
Lei più volte ha ripetuto che, una volta finita la guerra, ci sarà bisogno di una nuova leadership politica e anche religiosa, di volti nuovi e di una lingua diversa. Dopo circa 16 mesi di guerra ritiene ancora possibile questo rinnovamento?
Sulla necessità di una nuova leadership credo ci sia poco da discutere. Con tutto il rispetto, non credo che Abu Mazen e Netanyahu saranno gli uomini che avranno una visione aperta al futuro. La politica, poi, si fonda anche su una visione e narrativa religiosa. I coloni, i settler, hanno una narrativa religiosa molto chiara. Abbiamo bisogno di una leadership religiosa capace di elaborare una narrativa religiosa sulla Terra Santa solida, seria, fondata sulle Scritture, che non sia quella dei coloni. Questo per consentire, a livello culturale e interreligioso, di avere qualcosa di diverso e di importante da dire.
Com’è la situazione dentro la parrocchia latina della Sacra Famiglia che accoglie circa 500 rifugiati cristiani?
Con la tregua, a Gaza la situazione è cambiata. I cristiani respirano un po’, le bombe non cadono più. I rifugiati all’interno della parrocchia in questi giorni sono usciti per andare a vedere cosa resta delle loro case. Quasi tutti le hanno trovate rase al suolo, i più fortunati parzialmente distrutte e inagibili, senza acqua, senza luce, senza fognatura. Così sono tornati tutti in parrocchia dove hanno un tetto, del cibo e la scuola. Comincia adesso il tempo delle domande sul futuro loro e della Striscia. Nei prossimi mesi si capirà meglio il da farsi. Non dipende solo da noi. Se anche avessimo i mezzi per ricostruire bisogna capire cosa si può riedificare e dove.
Ricostruire una casa quando intorno non c’è nulla non serve a molto. Aspettiamo di capire se c’è o meno un piano, se i confini saranno aperti e a chi e a quali condizioni. Questa è la fase più difficile, capire come ricominciare.
In questo anno e mezzo circa di guerra, avete sentito la vicinanza della Chiesa universale?
Sì, certamente. Lo è stata da un punto di vista pratico, concreto e lo abbiamo anche reso pubblico. L’aiuto ricevuto ci ha permesso di fare cose che altrimenti non avremmo potuto fare, come fare entrare cibo a Gaza da destinare non solo ai nostri cristiani ma a tutti quelli che erano nel bisogno. Quando è stato lanciato l’appello per Gaza abbiamo ricevuto tanta solidarietà sia dai fedeli della nostra diocesi che da quelli delle Chiese di tutto il mondo, Africa, Estremo Oriente. Per noi è stato un gesto di vicinanza che ci ha fatto piacere.
Parlando di dialogo: “Nostra aetate”, il documento del Vaticano II sui rapporti tra la Chiesa cattolica e le religioni non-cristiane, compie 60 anni (1965-2025). Cosa ha ancora da dire questo testo nell’ambito del dialogo con l’ebraismo?
Ciò che è stato fatto grazie a questo documento è importante e non è ancora concluso. Ma credo che abbia finito la sua spinta propulsiva. Ora dobbiamo parlare di altro. In passato abbiamo sempre evitato di parlare di alcuni argomenti per non avere problemi. Ma adesso li abbiamo ugualmente. Mi riferisco a temi come l’interpretazione delle Scritture sul legame tra Israele e la terra, il rapporto particolare che il popolo di Israele ha con lo Stato di Israele.
Quali effetti ha avuto il 7 ottobre sul dialogo con gli ebrei?
È un fatto che dal 7 ottobre non riusciamo ad incontrarci.
Il 7 ottobre ha cambiato molto abbiamo bisogno di ricostruire le nostre relazioni e cercare di capire insieme su cosa ricostruire il rapporto.
Fino ad oggi è stato un dialogo, diciamo così di élite, condotto da studiosi ed esperti, ora bisogna far incontrare i parroci, i rabbini, gli imam, le comunità.
A proposito di comunità, incontrando diversi cristiani di Betlemme, si percepisce forte la loro paura del futuro e di restare confinati dentro il muro che li circonda o, peggio, di essere costretti a lasciare le loro terre…
Nessuno qui è emozionalmente libero di pensare al futuro. La guerra ha avuto un impatto forte sulle popolazioni e non c’è, adesso, questa libertà di guardare avanti. Si tratta di una situazione comune tra israeliani e palestinesi, seppur ciascuno con situazioni estremamente diverse tra loro.
In che modo scacciare questa paura dalla comunità cristiana?
Dobbiamo continuare a lavorare, a pregare, a dialogare. Alle nostre comunità dico sempre di agire come se non ci fosse la guerra. Anche a Gaza. Nella Striscia di Gaza, i fedeli della parrocchia della Sacra Famiglia fanno esattamente tutto come prima, liturgia, preghiera, scuola, assistenza umanitaria.
Non dobbiamo permettere che la guerra determini le nostre scelte.
Un altro punto è l’incontro: in questo momento ciascuno è chiuso in se stesso e per palestinesi e israeliani incontrarsi non è affatto semplice.
Un’ultima domanda: il 25 gennaio scorso, a conclusione della 58ª Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, Papa Francesco ha auspicato una data comune per la Pasqua, Che ne pensa?
Le relazioni tra le Chiese qui vanno molto meglio che nel passato. I lavori al Santo Sepolcro, (affidati all’università La Sapienza di Roma dalle tre comunità che gestiscono la basilica, greco-ortodossi, Custodia di Terra Santa per i cattolici latini e armeni, ndr.) ne sono un chiaro esempio. Per noi il rapporto con le chiese è una missione pastorale; tutte le famiglie sono miste e vogliono l’unificazione della Pasqua che noi abbiamo già fatto, almeno parzialmente, in Giordania dove tutti seguono la Pasqua ortodossa e il Natale cattolico. Lo stesso avviene a Cipro. In Terra Santa, per via dei pellegrinaggi, Nazareth, Betlemme e Gerusalemme seguono il calendario gregoriano, tutte le altre parrocchie quello giuliano.
Abbiamo consapevolezza che davanti alle Autorità civili dobbiamo avere un’unica parola su tutto, sulle tasse da pagare, sulla politica e via dicendo.