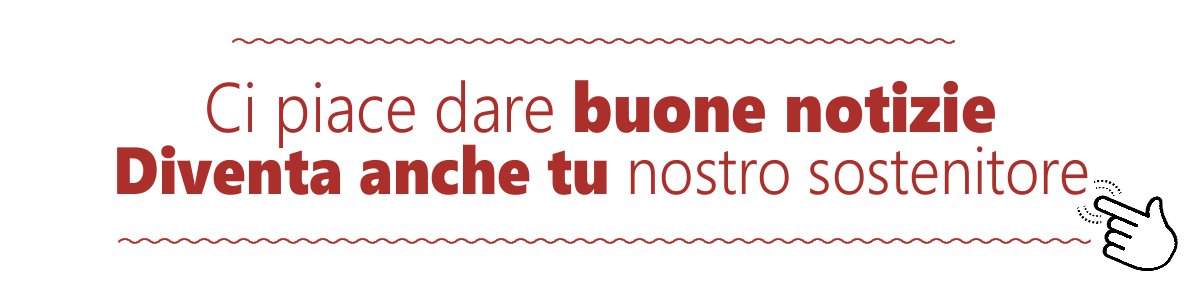“Finché c’è guerra c’è speranza”: i negoziati di Ryad e gli interessi in campo
Si rivelano le posizioni attorno al conflitto in Ucraina: i veli cadono, mostrando ambizioni e interessi effettivi

“Finché c’è guerra c’è speranza” è il titolo di un noto film del 1974 magistralmente diretto e interpretato da Alberto Sordi, oggi assai efficace nel sintetizzare le posizioni attorno al conflitto in Ucraina: i veli cadono, mostrando ambizioni e interessi effettivi.
I negoziati a Ryad tra Usa e Russia hanno appena affrontato lo sblocco del Mar Nero, la rimozione delle sanzioni su prodotti agricoli e fertilizzanti russi e la reintroduzione delle banche di settore nello Swift. La tregua sulle reciproche infrastrutture energetiche non decolla, così Putin propone per l’Ucraina un’amministrazione transitoria fino al rinnovo di presidente e parlamento, da tempo scaduti. Impossibile senza il sì di Kiev, ma il messaggio è chiaro: più si procrastina la resa, più l’esercito russo avanzerà, alzando la posta come accaduto sullo status del Donbass: sabotati gli accordi di Misk sull’autonomia speciale, si è passati all’indipendenza con la bozza di Istanbul, affossata la quale se ne è avuta l’annessione. Mosca non ha fretta di chiudere e indica in Zelensky un ostacolo, al pari delle armi che continua a ricevere da Washington, Parigi e Londra. Ma non hanno fretta neanche queste ultime, quando parlano di inviare truppe di interposizione senza il requisito della neutralità e il benestare di Mosca, quindi del Consiglio di Sicurezza.
La leadership ucraina paventa i rischi interni cui la esporrebbe una resa in questo momento. Trump rilancia sulla recalcitranza di Kiev e propone di estendere la mano Usa dalle terre rare ad agricoltura ed energia: la surroga dell’autonomia politico-militare appresa dal telefono della Nuland nel 2014 verrebbe così sostituita dalla cessione della sovranità economica concepita da Trump per cadere in piedi. La Casa Bianca fa leva sull’Ucraina per contrattare con il Cremlino le nuove geometrie multipolari, stante l’impossibilità di dettare l’unipolarismo con la zoppia della deindustrializzazione e con un hard power militare contestabile. Ciò spiega, assieme alla fame di terre rare, l’elusione di sfide frontali giacché, quando si è trattato di combattere piedi a terra ad alta intensità, dal Vietnam in poi, si è dovuto suonare la ritirata, come in Iraq e Afghanistan. Ma l’agenda Trump, nel prevedere tagli al Pentagono, si scontra in casa con il complesso militare-industriale e i fondi di investimento i cui addentellati, oltre che nei pacchetti azionari di varie holding editoriali, trovano in Europa anche riscontri politici.
Al di là dei sofismi nominalistici (da Rearm a Readiness 2030), basta il kit di sopravvivenza della Commissione a rivelare lo stimolo a una mentalità emergenziale, con il formidabile motore della paura funzionale. Ammesso che la Russia (11 fusi orari sottopopolati ma con risorse strategiche sufficienti al fabbisogno mondiale per 300 anni) sia in procinto di scatenare la fine del mondo, certo non aspetterebbe i 5 anni entro cui l’Europa dovrebbe riarmarsi. Vero è che questa non riuscirebbe a eguagliare la potenza del nemico: già ora spende quattro volte Mosca e oggi, visti i costi di energia e materie prime, sborserebbe il triplo dei bilanci militari ante 2022 solo per sostituire le dotazioni attuali. Ma l’opportunità – Draghi docet – è tutta finanziaria. Il risultato immediato consisterebbe in nuovi capitali liberati da dirigere sui titoli più attraenti: sgonfiata la bolla dell’hi-tech green per via della concorrenza cinese, esaurita la spinta farmaceutica, ora spetta al settore armi, in sinergia con i circuiti azioni delle assicurazioni private, favorite dai tagli al welfare.
Ma non mancano fughe solitarie. In Germania il cancelliere in pectore Merz, ex advisor BlackRock, con un colpo di mano ha riscosso dal parlamento uscente (nel nuovo, prossimo a insediarsi, non avrebbe avuto i voti necessari) la riforma del tetto costituzionale al disavanzo. È il via libera al riarmo con cui salvare l’industria automobilistica. Volkswagen infatti ha appena offerto a Rheinmetall gli impianti per sfornare carri. Poco male per i compagni d’armi, se non fosse che la concorrenza dei titoli tedeschi riduce gli spazi per vendere il debito di altri Paesi.
Francia e Regno Unito, orfani dei trascorsi imperiali, soffiano sul fuoco raggruppando i (pur poco coesi) Volenterosi per profittare dei vuoti di una Nato meno americana. Londra procede anche sola con accordi bilaterali e, memore delle mire ottocentesche sulla Crimea, continua a garantire con il Mi6 i pretoriani del governo di Kiev.
Anche la Polonia, oltre a rispolverare le rivendicazioni sulla Galizia ucraina, tiene al ruolo di smistatrice del gas norvegese anziché russo. Le repubbliche baltiche rivestono un peso in Commissione che le sovrarappresenta e lo usano per accreditarsi nella veste di preziose sentinelle tuonanti contro la minaccia russa. A parte la “russofilia” slovacca e ungherese, altri, come Spagna e Croazia, cercano di sfilarsi da simili foghe. Ma c’è anche chi scommetteva su Kiev e ora teme che gli Usa calino l’asso pigliatutto sui piani per la ricostruzione abbozzati nel 2023. Allora il governo italiano invitava gli imprenditori a prepararsi al dopoguerra; oggi patisce l’equilibrismo tra Ursula e Tycoon. Il che non impedisce di agganciare Leonardo al rimorchio inglese o alla joint-venture con Rheinmetall.
Quanti parlavano di pale e lavatrici adesso preparano ricette in cui la guerra resta ingrediente profittevole, ma gli attentati suicidi delle due madri ucraine nei commissariati del reclutamento forzoso sono un’icona dura da digerire. E se con esse tirassimo tutte assieme le conclusioni di questi tre anni potrebbe non servirebbe annullare le elezioni per arginare gli effetti della delegittimazione.
Il film di Sordi merita di essere rivisto: auguriamoci di non riconoscerci nel cinismo della scena finale, dove i familiari del mercante d’armi, pur indignati, tornano a fingere di non sapere, temendo di perderne gli agi dello stipendio.
Giuseppe Casale*
*Pontificia università lateranense, Scienze della pace