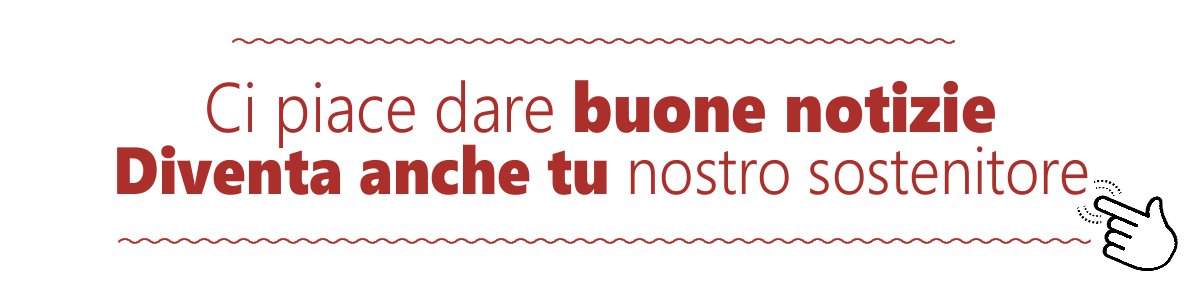Ora, labora et lege. Nel monastero benedettino di S. Giovanni Battista, fondato nel VIII secolo da Carlo Magno
Le mura del monastero respirano lo spirito benedettino dal 1244 anni

La bacchetta di metallo incontra il bronzo e l’eco del suono si diffonde ovattata per il chiostro. Uno, due, tre colpi su quella particolare campana a rintocchi, che risuona instancabile dal XII secolo ad oggi.
“+Dulcem (-dat s)onum – veniat – pia – turba – sororum”, “se emette un dolce suono, il pio gregge di sorelle si affretta a venire”.
Siamo a Müstair, in Svizzera, a meno di 3 chilometri da Tubre (Val Venosta), nel monastero benedettino di S. Giovanni Battista, fondato nel VIII secolo da Carlo Magno. Nel XII secolo i monaci lasciarono spazio alle monache, che ancora oggi continuano a vivere secondo la regola del loro fondatore “ora, labora et lege”: preghiera, lavoro e letture spirituali. Le mura del monastero respirano lo spirito benedettino dal 1244 anni. Non solo. Il complesso monastico di Müstair è il più importante sito di ricerca archeologica ed edilizia altomedievale di tutta Europa.
Nel 1983, in occasione della riunione del Comitato del patrimonio mondiale tenutasi a Firenze dal 5 al 9 dicembre, il convento benedettino di San Giovanni è stato iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Insieme al quartiere abbaziale di San Gallo e alla città vecchia di Berna, ea siti dai nomi altisonanti, come Machu Picchu e Taj Mahal.
L’intero complesso monastico è di fatto il più grande e meglio conservato ciclo di pittura murale dell’Alto Medioevo e le pitture romaniche della chiesa e del monastero sono di livello mondiale. La chiesa ospita, inoltre, la più antica statua monumentale di Carlo Magno, un tempo dipinta a colori.
“Ringrazio Carlo Magno di aver fondato questo monastero”. A parlare è sr. Domenica Dethomas. È entrata in convento a 25 anni e da allora vive a soli 100 metri dalla casa in cui è nata e cresciuta, dietro le mura storiche del convento. Dal 2013 al 2019 è stata priora della comunità. Ha raccolto il testimone da sr. Pia Willi, oggi ultranovantenne, che ha guidato il convento per oltre 26 anni e che ancora oggi è attiva nella comunità disegnando le cartoline che vengono vendute nel piccolo negozio adiacente al convento.
Sr. Domenica, che di anni oggi ne ha 80, racconta di Carlo Magno seduta nel chiostro del convento, in un assaggio di intervista pubblicato in anteprima sulla pagina Ig del monastero. “È arrivato qui con le sue dieci mogli – ricorda sorridendo e agitando la mano in segno di rimprovero – Era la moda di allora”. Quella di sr. Domenica è una delle video interviste che fanno parte della nuova sezione del museo del convento, inaugurata nel tardo pomeriggio di lunedì 24 giugno, memoria liturgica di s. Giovanni Battista.
“Innenleben. Die barocken Nonnenzellen” è il titolo del nuovo percorso che va ad arricchire il museo, che dal 2003 è ospitato all’interno della “Plantaturm” e che in un primo tempo era stato realizzato in una parte del convento oggi divenuta clausura. La torre prende il nome dall’allora badessa Angelina Planta (1478-1509), ma a costruirla non è stata lei. Analizzando i cerchi delle travi in legno usate come rinforzo nella muratura, gli archeologi hanno calcolato che quel legno è stato abbattuto nell’autunno/inverno 957/958 e nella primavera del 961. E così la Torre Planta è di fatto la più antica torre residenziale e di difesa della regione alpina.
L’idea di creare un museo è di Raphael Sennhauser, storico dell’arte ed ex direttore della Fondazione Pro Kloster St. Johann di Müstair. L’obiettivo era quello di raccontare la vita del monastero in quella torre, che per molti anni ha ospitato le monache, proteggendole dalle battaglie che si consumavano al di là delle mura del monastero. All’epoca le circa 30 monache riposavano in un unico grande dormitorio, senza riscaldamento ma dotato di una latrina che dava direttamente all’esterno dell’edificio. In epoca barocca, per ovviare soprattutto a problemi di natura igienica, è stato ristrutturato il secondo piano della torre, dove sono state ricavate le cellette per le monache; le abbadesse, generalmente figlie di famiglie nobili, avevano a loro disposizione un piccolo appartamento all’interno del monastero con tanto di stufa in maiolica.
Su iniziativa dell’allora priora Pia Willi si sono iniziate a ristrutturare le cellette in legno, dove oggi i visitatori del museo possono fare “una visita nella visita”, andando a scoprire come vivevano le monache in quell’epoca. Le stanze, divise da tramezze in legno, erano di dimensioni assai contenute; c’era spazio per un piccolo tavolino, un angolo con il crocifisso per la preghiera e un letto (lungo circa 1,2 metri), che a guardarlo oggi parrebbe quello di un bambino. Questo non tanto perché allora le persone fossero di bassa statura, quanto piuttosto perché nel medioevo non vi era la consuetudine di dormire sdraiati. Chi giaceva sdraiato era chi, ormai, era senza vita. Si dormiva, quindi seduti. E questo veniva incontro anche ai non pochi problemi respiratori che affliggevano la comunità in quel tempo: la mancanza di riscaldamento nelle celle e il termometro che per la gran parte dei mesi dell’anno rimaneva fisso sotto lo zero, facevano ammalare spesso di bronchite o polmonite. E poi c’erano i problemi d’asma. Un piccolo scaldino in metallo conteneva dell’acqua bollente, che le suore utilizzavano al mattino per lavarsi, dal momento che quella nella brocca era generalmente congelata.
Sbirciando tra le celle – che il Sir ha avuto modo di visitare in anteprima – si scorge anche una stanzina in cui sono conservati dei piccoli cofanetti intagliati in legno. In essi era contenuto tutto quello che veniva permesso tenere alle ragazze che entravano in convento in giovanissima età. I ricordi della loro famiglia e della loro infanzia racchiusi spesso in scrigni grandi meno di un foglio A4. E poi c’è anche una cella in cui si racconta il miracolo dell’ostia del Sangue Santo. Siamo nel XIII secolo. Gli annali del convento narrano che “la monaca Agnese, figlia di un cavaliere di Sent, nella Bassa Engadina, ricevette l’ostia un giovedì santo con coscienza incerta, ma poi non ne prese parte, ma la nascose nel suo velo e la conservò sul suo petto; quando poi osservò come l’ostia si trasformava in carne e sangue, rivelò la sua esperienza al sacerdote del monastero”. Per custodire la reliquia venne costruita nel 1758 la Cappella delle Grazie. Nel 1799, 41 anni dopo la costruzione della cappella, la reliquia venne rubata dai francesi durante la seconda guerra di coalizione. La cappella rimane tuttora meta di pellegrinaggi. Sulla parete ovest sono appesi gli ex voto. I visitatori ancora oggi possono scrivere le loro preghiere o ringraziamenti su una sorta di segnalibro di cartoncino, decorato con una rosa di carta e appenderlo alla grata in legno bianco che decora la parete. A prendersi cura della Cappella è l’attuale priora, sr. Aloisia Steiner di Tubre. Rimuove regolarmente i cartoncini dalla pergola per inserire le preghiere all’interno delle preghiere della comunità.
Oggi nel monastero vivono 9 monache benedettine di clausura; la più giovane ha superato i 60 anni. Nei momenti di massima fioritura di vocazioni la comunità monastica era composta da oltre trenta monache, mentre negli anni della peste tra le mura del convento erano rimaste solo in due. Ma la comunità non è stata chiusa nemmeno in quell’estrema situazione di necessità. E questo per far sì, che in quel luogo, patrimonio di arte, storia, ma soprattutto di fede, continui ad essere portata avanti la regola di san Benedetto “ora, labora et lege”.