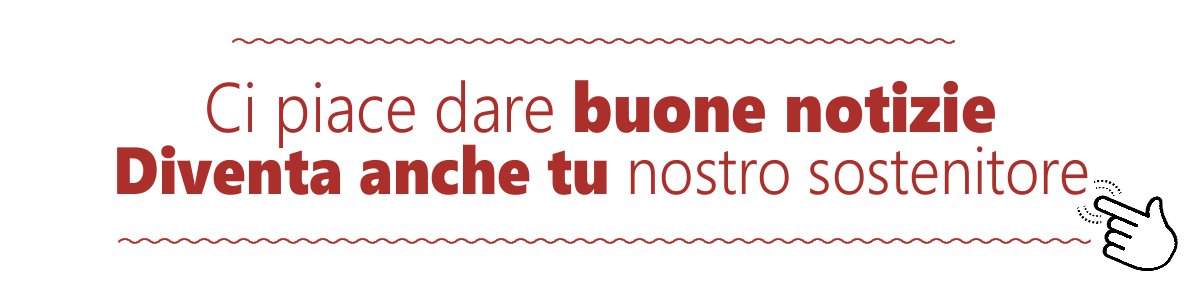San Pietro, scrigno ricolmo di misteri
Il ministero per i beni culturali ha stanziato 600 mila euro per la messa in sicurezza sismica della chiesa di San Pietro lesionata dal terremoto del 2012

Lo stanziamento di 600 mila euro del Ministero per i beni culturali per la chiesa di San Pietro a Padova è importante. Non solo perché si spera garantisca la “prevenzione ai rischio sismico” di un tempio lesionato in modo preoccupante dal terremoto del 2012 nella parete laterale del presbiterio, oggi inagibile. Chiusura che non pregiudica la fruibilità della navata e delle celebrazioni, attraverso un altare provvisorio in legno. Ma anche perché consentirà (e qui un altro “si spera” è d’obbligo), di studiare in modo più accurato e completo di quanto non sia stato finora possibile un edificio antichissimo, che si presenta oggi con una storia complessa e per buona parte ancora sconosciuta. Basti dire che già la benemerita docente del Tito Livio Cesira Gasparotto, appassionata studiosa di storia cittadina, in un suo vecchio saggio faceva notare come la chiesa, che sorge nell’omonima via e pertiene alla parrocchia della Cattedrale, fosse nominata “in Palatio” nel privilegio del 2 aprile 866 con cui l’imperatore Ludovico II la dona al vescovo di Padova.
«La denominazione – spiega la professoressa Giovanna Alchini, che, in onore della sua insegnante, ha continuato a studiare questa chiesa – indica che San Pietro era adiacente al “palatium publicum” imperiale, quello in cui soggiornavano gli imperatori quando venivano a Patavium, edificio insigne per importanza e forse per magnificenza. Era quindi una cappella palatina, una chiesa abbaziale di fondazione e proprietà imperiale, quella donata al vescovo di Padova, accanto alla quale nel 1026 il vescovo Orso erigerà il monastero femminile benedettino facendogli una ricca donazione. Di quella primitiva chiesa resta ben poco, però alcuni scavi eseguiti nel sottosuolo hanno portato alla luce pavimenti a mosaico probabilmente tardo romani e romanici e grossi blocchi di pietra, tuttora visibili nel giardino delle suore Dorotee. Tanto altro potrebbe essere individuato con un’esplorazione georadar su un sito che si è rivelato quanto mai promettente.
Rovinata dagli Ungari nell’899, la chiesa è stata rifatta prima di diventare il polo liturgico delle “canonichesse” (un titolo che ricorda l’antica dipendenza dal sovrano) benedettine. Viene probabilmente distrutta un’altra volta dal terremoto del 1117, lo stesso che sconquassò la cattedrale e la basilica “opilioniana” di Santa Giustina. Oggi la chiesa appare un grande puzzle composto da elementi forse trecenteschi, da residui di restauri-rifacimenti del 1480 e poi del 1580-84, a cura della badessa Angela Alvarotti, e dagli “abbellimenti” ottocenteschi promossi dall’arciprete della Cattedrale Vincenzo Scarpa. Tutti elementi che hanno bisogno di restauro e, ribadiamolo ancora una volta, di uno studio complessivo sulla chiesa, che tuttora incredibilmente manca. Nel 1765 un altro tassello di grande suggestione: è stata realizzata la cappella a destra del presbiterio, esattamente sul modello della Santa Casa di Loreto, i cui affreschi hanno bisogno urgente d’intervento per non vederli svanire irreparabilmente.
La comunità delle religiose benedettine visse qui per secoli, fino alle soglie del 19° secolo e alla tempesta napoleonica: accolse nel 1806 le suore del soppresso monastero di San Prosdocimo, insieme alle spoglie della loro beata, Eustochio (vedi pagina seguente), ma fu a sua volta chiusa nel 1810. Il monastero divenne proprietà privata e la chiesa passò prima sotto la parrocchia di San Leonardo, a sua volta soppressa nel 1811, e poi sotto la Cattedrale, sotto la cui giurisdizione si trova tuttora. Numerose e suggestive le opere d’arte conservate al suo interno, dalla Consegna delle chiavi a San Pietro, di Dario Varotari alla Conversione di san Paolo di Palma il Giovane, fino alle due pale ottocentesche di Giacomo Manzoni e alle tempere absidali del primo Novecento di Giovanni Vianello, che offrono un racconto della vita di san Pietro, oggi offuscato dalla polvere e dal degrado. Seicentomila euro sono un primo passo, un segno d’interesse che San Pietro si merita pienamente.