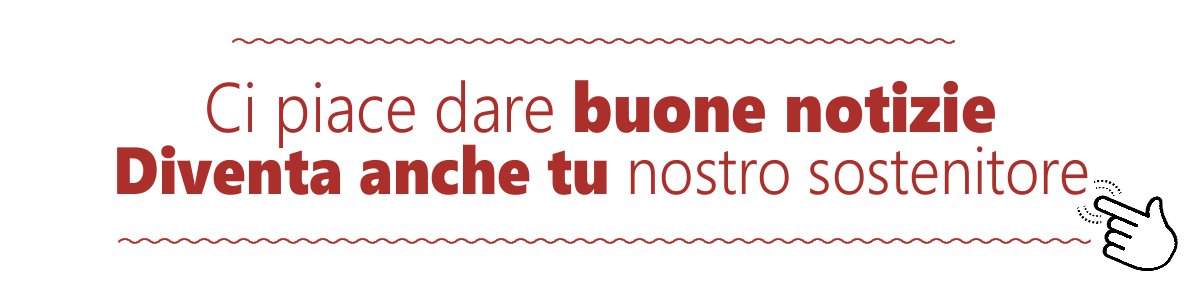Non sono solo canzonette. Il fondamentale ruolo della letteratura nei testi della musica contemporanea
La canzone deve molto alla letteratura: un tempo l’unico veicolo delle poesie era il cantarle

Non è solo per il De Andrè di “La buona novella”, dove furono i vangeli apocrifi, specie il Protovangelo di Giacomo e il Vangelo arabo dell’infanzia, a farla da protagonisti, né l’Angelo Branduardi di “Secondo Ponzio Pilato” o dell’”Infinitamente piccolo” dedicato a Francesco d’Assisi, come anche il “Forza venite gente” di Mario Castellacci e tanti altri episodi in cui fede e canzone si incontrano. Perché quell’incontro è la punta di diamante di un fenomeno spesso ignorato dagli stessi esperti: la canzone deve molto alla letteratura: un tempo l’unico veicolo delle poesie era il cantarle, come all’epoca dei trovatori, e se ci pensate bene c’è un episodio più tardo, siamo ai primi del Trecento, che avrebbe dovuto aprirci occhi e orecchie: nel secondo canto del Purgatorio si presenta un personaggio di cui sappiamo ben poco, un cantore di nome Casella, che aveva interpretato alcuni sonetti e canzoni di Dante. Lì, dopo un commosso incontro, egli intona “Amor che nella mente mi ragiona”, una canzone presente nel Convivio dantesco. Sì, avete capito bene, nel medioevo erano già belli e fatti i ruoli di cantante, autore delle musiche, autore delle parole.
E perciò non stupiamoci se quei confini non sono così netti: pensiamo al connubio Lucio Dalla e Roberto Roversi, uno dei più importanti poeti di metà Novecento, che rinnovò il panorama della canzone italiana del periodo e che creò, tra i tanti, un capolavoro come “Tu parlavi una lingua meravigliosa”.
E, se vogliamo renderci veramente conto di come quel rapporto sia davvero profondo, più di quanto ci abbiano abituato a pensare, dobbiamo addirittura andare al cosiddetto progressive rock, una musica molto avanzata che ebbe tra i suoi campioni un gruppo partenopeo, gli Osanna. Perché quel gruppo realizzò una canzone, dal sottotitolo medioevale di “Canzona”, che rimandava letteralmente ad alcuni passi dell’Ecclesiaste, anche attraverso la mediazione di una poesia di Eliot, “Il canto d’amore di Prufrock”, in cui si sottolinea che c’è un tempo per ogni cosa, ovviamente con i cambiamenti dovuti al passare dei secoli e degli stili.
Ma se è per questo anche certe canzoni di Bob Dylan rimandano allo spirito profetico di alcuni passi della Bibbia. Ed è così che composizioni apparentemente incomprensibili di un gruppo come i Procol Harum (è loro la celebre “A whiter shade of pale”), tra i primi a mescolare suoni sinfonici alle chitarre elettriche, avevano a che fare con la fascinazione del medioevo anglo-sassone dei Canti di Ossian e delle visioni magiche dei cicli epici arcaici, cui noi non siamo abituati.
Ma anche la letteratura popolare, cui si rifecero lo stesso Dylan come anche Donovan, un cantautore assai attento a quelle radici, ha un ruolo chiave: i cantanti vagabondi parlano di antichi amori abbandonati per andare a lavorare lontano o per divieti familiari, con la preghiera al passante che sta per recarsi ad una fiera di paese di portare un saluto d’amore all’antica passione. Tema ripreso sempre dal Dylan di “Girl from the north country”, ma anche da Simon and Garfunkel con “Scarborough fair”, ripreso come colonna sonora, assieme a “The sound of silence”, del celebre film “Il laureato” con Dustin Hoffman come protagonista. E anche il nostro cantante folk Gian Pieretti seguì quel filone con “Il vento dell’est”.
A proposito di “Il suono del silenzio”: questa canzone è stata giustamente considerata una delle più belle della storia della musica, e, secondo alcuni, tra cui chi scrive qui, una vera e propria profezia novecentesca, con quell’ attualissimo -eravamo nei primi Sessanta- “Le parole dei profeti / sono scritte sui muri della metropolitana/ e negli ingressi delle case popolari”.
No, non sono solo canzonette.