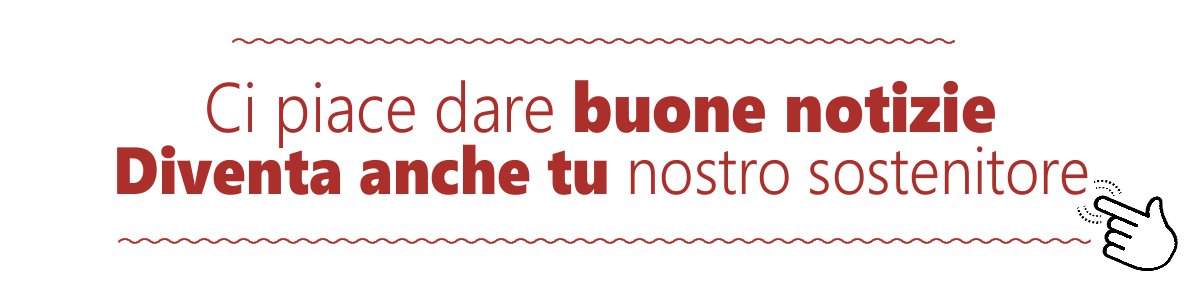Sui fiumi passavano i burci carichi di materiali e feriti
La mostra fotografica “Acque di battaglia”, fino a metà febbraio al museo della Terza armata di Padova, esplora un capitolo sconosciuto del conflitto: il contributo dato dal genio lagunari attraverso il trasporto di un milione e mezzo di tonnellate di materiali e di persone attraverso la rete di fiumi e di canale lagunari verso il fronte del Carso e poi del Piave.

Per analogia con i “campi di battaglia”, s’intitola “Acque di battaglia” la mostra che resta aperta fino al 15 febbraio al museo della Terza armata di Padova.
L’esposizione, realizzata in collaborazione con il centro internazionale Civiltà dell’acqua, è curata da Mauro Scroccaro, autore di varie ricerche analoghe, e punta l’obiettivo su un aspetto poco noto della prima guerra mondiale: l’organizzazione di quel particolare settore della logistica che si attuava attraverso i trasporti lagunari e fluviali.
«Un settore niente affatto secondario – spiega Scroccaro – se si pensa che in questo modo sono state spostate un milione e mezzo di tonnellate di materiale utilizzando più di 1.500 natanti. Si trattava di chiatte, battelli e rimorchiatori a pala, per potersi muovere anche in acque basse, che il corpo speciale del genio lagunari, dapprima sezione del genio pontieri, che arrivò a contare più di cinquemila persone, muoveva su 1.700 chilometri di reti navigabili da Milano a Grado. Una rete di canali che fu in parte realizzata ad hoc, come la litorale veneta».
Cosa si trasportava via acqua, nei fiumi e nella laguna veneziana?
«Verso il fronte – spiega Scroccaro – prima il Carso e poi il Piave, venivano trasportati i materiali ingombranti che avrebbero collassato la rete ferroviaria e stradale: legname dai boschi alpini della Lombardia, carbone, fieno. Da Monselice, per toccare una delle zone del Padovano interessate da questa rete, veniva organizzata una linea sistematica di trasporto del pietrisco usato per i fondi stradali e per quelli delle trincee. Quando il fronte si attestò attorno al Piave, furono trasportati anche molti soldati in zone che non erano raggiungibili se non via acqua. Solo durante la battaglia del Solstizio furono fatti arrivare in questo modo più di 50 mila uomini. Dal fronte le barche trasportavano i feriti. Soprattutto sul Sile i militari venivano imbarcati a Porto Fiera a Treviso su specifiche ambulanze fluviali della Croce Rossa per essere ricoverati negli ospedali interni, Venezia, Chioggia, ma anche Piacenza, Cremona, Pavia».
La rete era strutturata come un sistema ferroviario su fiume, con trazioni, scali, orari sistematici di passaggio dei vari convogli trainati dai rimorchiatori.
Dove non era possibile il traino, nelle reti più interne, come sul Bacchiglione o sul Sile, si ricorreva al tradizionale alaggio dei burci lungo le rive, con i cavalli del genio lagunari, che aveva una grande scuderia a Jesolo, o attraverso l’appalto a contadini che mettevano a disposizione i loro animali. Proprio in questa circostanza furono abbattuti gli ultimi secolari mulini del Bacchiglione.
Dopo Caporetto, per inciso, la parte della rete fluviale rimasta in zona nemica, che da Trieste giungeva fino a Caorle, fu utilizzata dagli austriaci che istituirono un analogo corpo militare, composto perlopiù da istriani e triestini.
Una sezione a parte della mostra è dedicata alle difese approntate in laguna alle spalle della prima linea per fermare eventuali sfondamenti sul Piave. Ci sono immagini di decine di chilometri di trincee sopraelevate sulla laguna per contrastare eventuali sbarchi.
La mostra sarà ospitata entro l’anno anche nel museo della navigazione interna di Battaglia Terme.