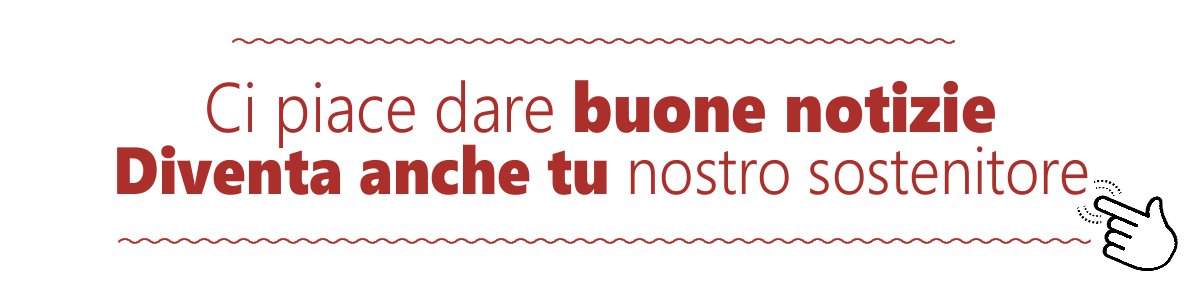Per un nuovo umanesimo. In un recente libro vengono ricordati padre Balducci, Aldo Capitini e don Lorenzo Milani
Paolo Levrero, “La libertà si impara. Figure del Neoumanesimo pedagogico italiano: Balducci, Capitini, Milani” (Libreria Editrice Fiorentina)

Umanesimo come nuova e insieme antica ricerca di valori, per una esistenza che sappia armonizzarsi con il creato, nel qui e nell’ora, ma nel contempo cercando le tracce dell’eterno in noi. Questa potrebbe rappresentare la sintesi delle tre grandi esperienze di padre Ernesto Balducci, don Lorenzo Milani e Aldo Capitini che Paolo Levrero, docente all’Università di Genova, affronta nel suo “La libertà si impara. Figure del Neoumanesimo pedagogico italiano: Balducci, Capitini, Milani” (Libreria Editrice Fiorentina, 139 pagine, 15 euro). Un umanesimo che attraversa le distinzioni fuorvianti tra laico e religioso, e che guarda alla totalità dell’essere umano nel suo porsi in ascolto delle voci dell’io profondo e dell’Altro.
Non è un caso che Balducci e Milani fossero consacrati e che nel contempo si siano posti concretamente in ascolto degli emarginati, degli esclusi e dei miseri abbandonati a loro stessi. In poche parole, come scrive l’autore, parlando di Balducci, “la condizione umana del povero”. Non però profeti di sventure, ma attivi protagonisti del loro tempo, attraversando la politica come la fede e la letteratura, perché, ricorda giustamente Levrero, lo stesso Balducci ravvisò nell’opera narrativa di Antonio Fogazzaro, che dovette fare salati conti con la sua vicinanza al modernismo, soprattutto con “Il santo”, un fondamentale tentativo di indagare il dissidio tra spirito e materia. E il Concilio Vaticano II vedrà Balducci percorrere quell’itinerario storico a contatto con la nuova teologia e con i problemi che poneva la contrapposizione oriente-occidente, liberismo economico e socialismo “reale”.
Il concetto di comunità è il sottile ma resistente filo rosso che attraversa le tre storie qui narrate. Anche nel caso di Aldo Capitini, profeta della pace che ha condiviso l’insegnamento di Gandhi -e prima di lui Tolstoj, che il Mahatma ha considerato come maestro- pace significa essere insieme, guardare all’altro non come ostacolo ma in quanto compagno di viaggio in un mondo da conservare e consegnare all’altro.
La religione è in questa prospettiva un elemento fondante, soprattutto nella figura di san Francesco, perché il poverello d’Assisi ha fattivamente operato nella comunione con il creato, oltre ad averlo consegnato al cuore della letteratura vivente con il Cantico. E non è un caso che la cultura di Capitini attraversi il pensiero critico d’Occidente, e dopo il magistero di Kant e Kierkegaard si avvicini a quello di Ibsen, Jahier o Slataper: queste concezioni del mondo ponevano la drammatica scelta tra un esistenzialismo ripiegato su se stesso e la ricerca di una via d’uscita che unisse il sacro e l’umanità in una nuova concezione dell’esistente. Ed è proprio questa la base della sua pedagogia umanistica.
Una pedagogia che viene concretizzata da don Lorenzo Milani, il quale abbandona il perbenismo e il lusso per iniziare una nuova strada. Un libro, questo, che ci fa capire come sia tra le due guerre sia dopo la seconda l’affermazione del liberismo economico abbia rappresentato da una parte un maggiore benessere economico, ma dall’altra abbia gettato le fondamenta di una società in cui quel benessere occupava il centro del sistema.
Come aveva capito bene don Milani la tolleranza aveva lasciato il posto all’indifferenza. Solo la condivisione, l’accettare ciò che i benestanti chiamavano povertà e emarginazione, e non la semplice critica ideologica, sembrano dirci i protagonisti di queste storie, ci rende capaci di mettere davvero in pratica l’insegnamento del Cristo.