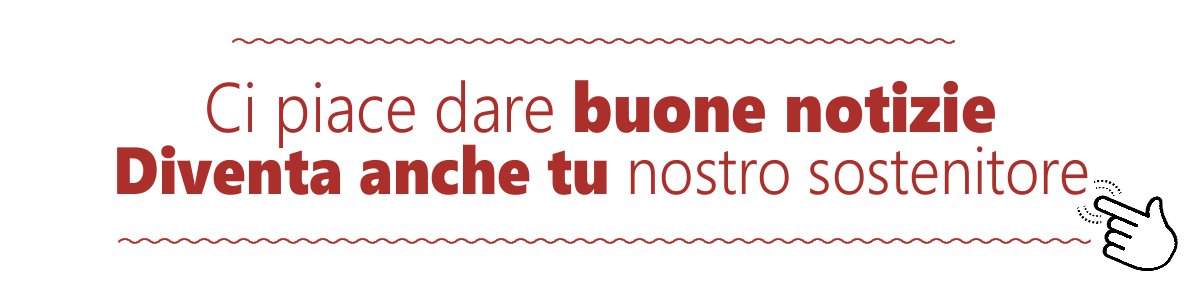Politica e magistratura, due poli in corto circuito
Dov’è finito il sapiente equilibrio dell’ordinamento disegnato dai Costituenti?

I rapporti tra politica e magistratura, così come emergono dalla Costituzione, sono disciplinati da regole chiare, ispirate a quel principio fondamentale per ogni vera democrazia che è la separazione dei poteri, da cui discende l’autonomia e l’indipendenza degli stessi nei loro ambiti di competenza. Certo, declinare i criteri generali nelle situazioni concrete è di fatto un’operazione complessa e quindi suscettibile di interpretazioni divergenti. Ma il quadro complessivo è ben definito: la politica fa leggi, la magistratura le applica. Per i casi controversi c’è un apposito organismo a cui rivolgersi in ultima istanza: la Corte costituzionale, composta da soggetti qualificati e designati in parti uguali dal Parlamento, dalla magistratura e dal Presidente della Repubblica. Sia i politici che i magistrati sono sottoposti alle leggi e rispondono ad esse. Con qualche limite che è bene ricordare a onor di cronaca: processare un membro del governo per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza. L’attuale esecutivo ha una maggioranza blindata in Parlamento: quindi nessuno, dalla premier in giù, corre effettivamente alcun rischio.
Questa, espressa in modo estremamente semplificato, è la fisiologia del sistema, a cui però bisogna aggiungere almeno un altro elemento: in forza del fondamentale art.11 della Costituzione, nel nostro Paese sono in vigore norme, in certi casi sovraordinate a quelle nazionali, che provengono da altri soggetti rispetto ai quali l’Italia ha deciso di limitare parzialmente la propria sovranità per fini di pace e giustizia tra le Nazioni. Se le coordinate, quindi, sono così limpide, com’è possibile che ciclicamente – e a cicli sempre più ravvicinati – politica e magistratura vadano in corto circuito com’è avvenuto e sta avvenendo in questi mesi? Le criticità più gravi – non già la normale dialettica istituzionale in un Paese libero e pluralista – emergono quando i protagonisti in campo fuoriescono dai binari e, per di più, non riconoscono i rispettivi deragliamenti. In questo campo verrebbe da scomodare l’evangelico “chi è senza peccato scagli la prima pietra”. A volte non c’è neanche il peccato, ma chi ricopre incarichi pubblici di estrema delicatezza dovrebbe preoccuparsi anche dell’impressione che dà di sé pubblicamente, fermo restando che spesso sono i comportamenti dei singoli o di una minoranza che finiscono per gettare una luce negativa su intere categorie. Dov’è finito il sapiente equilibrio dell’ordinamento disegnato dai Costituenti? Il dibattito pubblico sembra descrivere una situazione in cui a una magistratura politicizzata si contrappone una politica smaniosa di mettere sotto tutela la magistratura. Come schema interpretativo è verosimilmente troppo rigido. Ma la seconda tendenza evidenziata trova importanti riscontri anche in altri Paesi, al di qua e al di là dell’oceano, purtroppo con rilevanti consensi in un’opinione pubblica drammaticamente condizionata dagli oligarchi del digitale. Da noi per ora questo avviene solo in parte: quegli stessi, autorevoli sondaggi che vengono citati a piene mani per la popolarità registrata da questo o quel leader, avvertono che nello stesso tempo sono in forte aumento incerti e astenuti.