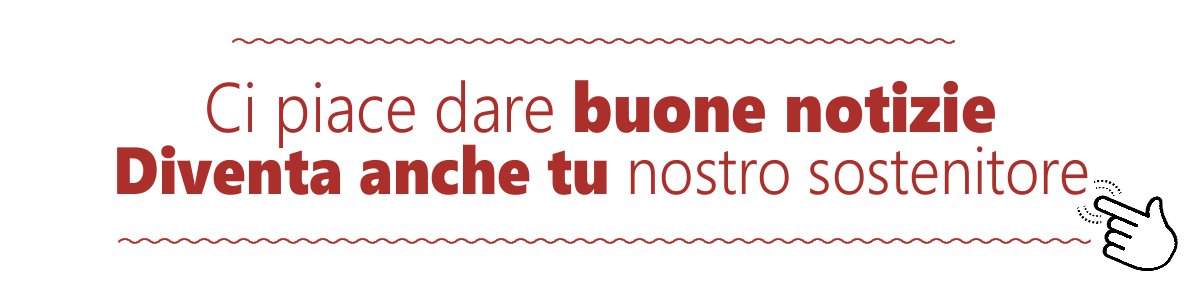Nel disinteresse dei media le sofferenze in guerra. Scrive Giuseppe Caramazza, missionario comboniano
Quale umanità? C’è più interesse a raccontare i combattimenti, gli incontri per il cessate il fuoco. Le vite delle persone colpite dai conflitti rimangono sfocate

Ben si sa che l’attenzione della gente verso fatti eclatanti dura solo per un tempo limitato. È stato così per la guerra dell’Ucraina, di cui ora si parla solo di rado. È stato così degli eventi nel Medio Oriente, l’attenzione ora si è spostata da Israele alla Siria. Tristemente è così dei conflitti nei Paesi più poveri del mondo, di cui non si parla mai. Credo che la maggioranza dei lettori sarebbe sorpresa dal sapere che i conflitti in corso nel mondo sono circa settanta! Alcuni sono conflitti interni – vedi Congo, Sudan, Etiopia, Messico, Colombia – altri coinvolgono due o più Paesi. Molti i conflitti fomentati da Nazioni esterne o in cui anche le Nazioni europee hanno interessi non sempre puliti. È il caso dei conflitti interni in Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, e Somalia. Qui, i Paesi dell’Unione Europea intervengono con armi, addestramento dei soldati e personale militare, spesso all’insaputa dei loro cittadini. A farne le spese, sul campo, non sono le forze militari, ma la popolazione. Solo in Africa, si parla di oltre 40 milioni di sfollati (sfollati interni e rifugiati in altri Paesi), più del doppio rispetto al 2016. Nel 2024, oltre 10 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le loro case e cercare rifugio altrove. Nessuno sa per quanto tempo queste persone dovranno rimanere lontane dalle loro case, dai loro campi, dalla possibilità di condurre una vita serena. Si sa, però, che la maggioranza non tornerà a casa per almeno una decina di anni. I bambini faranno fatica a ricevere un’educazione scolastica adeguata, i loro titoli di studio non saranno riconosciuti o verranno considerati di valore inferiore alla media. Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, venne istituito il campo profughi di Kakuma, nel nord del Kenya. Oggi, il campo raccoglie oltre duecentomila rifugiati provenienti da vari Paesi africani, la maggioranza sotto i 30 anni di età, molti dei quali passati nel campo. E questo è solo un esempio.
Qualche anno fa, in un campo rifugiati in Malawi gestito dall’Organizzazione delle Nazioni unite, incontrai un giovane Burundese. A soli due anni scappò con la famiglia in Tanzania. Dopo qualche anno, ritornò in Burundi ma dovette subito fuggire. Dei miliziani attaccarono il suo villaggio, uccisero il figlio di pochi mesi, la moglie uscì completamente di senno. Mi chiese di aiutarlo, sperava di poter frequentare l’università e cercare di ricostruirsi una vita. La sua speranza era quella di arrivare a una qualifica che gli permettesse di uscire dal circolo vizioso dei campi per rifugiati. Essere rifugiato vuol dire non avere diritto a un permesso di lavoro, a un passaporto, a una speranza. Lo misi in contatto con un gruppo dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati che gestiva l’università a distanza nei campi per rifugiati in Kenya. Allo stesso tempo mi chiesi che cosa avrebbe potuto veramente fare un giovane senza patria, senza famiglia, e con soli ricordi negativi a gravare sul suo passato. In un sito ufficiale dell’Ue (qui il link di rimando www. eeas.europa.eu) si legge che «la protezione della pace e della sicurezza internazionali è all’ordine del giorno dell’Unione europea sin dalla sua creazione... L’Unione europea e i suoi Stati membri sono impegnati in tutti i teatri bellici per contribuire alla risoluzione e sensibilizzare alla prevenzione dei conflitti e alla promozione della pace». Purtroppo queste belle parole cozzano con l’impegno profuso dagli Stati membri per addestrare eserciti nazionali, ma anche gruppi armati che non fanno capo ad un governo democraticamente eletto. È il caso del Sudan, dove sia l’esercito che i gruppi di ribelli che lo combattono hanno ricevuto addestramento e armi da governi europei, Italia inclusa. Purtroppo la sofferenza creata dalla guerra non è sempre ben descritta dai media. C’è più interesse a raccontare i combattimenti, gli incontri internazionali per raggiungere un cessate il fuoco, l’investigazione delle cause e degli interessi politico-finanziari. L’aspetto umano viene messo in secondo piano. Le vite delle persone colpite dai conflitti rimangono sfocate, in un sottofondo poco interessante per il circolo mediatico. A parlare di questi temi rimangono le testate missionarie e le testimonianze di chi lavora a favore della popolazione. Due voci che hanno poca eco nella coscienza generale. È quindi importante che chi viene a contatto con la sofferenza causata dalla guerra diventi una cassa di risonanza, per dar voce a chi, con la guerra, ha perso la possibilità di costruire il suo futuro.
Giuseppe Caramazza
Missionario Comboniano, è stato redattore della rivista Nigrizia, tra i fondatori del Catholic Information Service for Africa, agenzia giornalistica africana con sede a Nairobi, Kenya