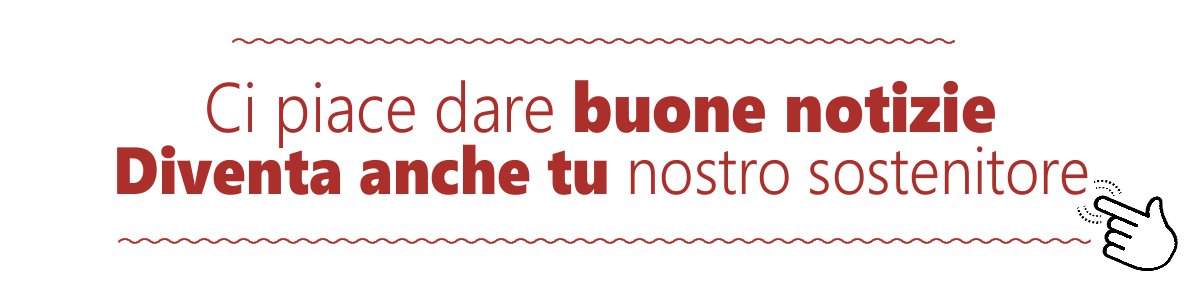Il Papa e la politica. Alla radice di essa c’è il “Popolo di Dio”
La politica, nel pensiero di Francesco, dev’essere fraterna, intendendo la fraternità in campo politico non in maniera intuitiva o affettiva, ma come un principio regolatore dei progetti politici

La visione che Papa Francesco aveva della politica si coglie facilmente se si comprende l’idea che egli aveva del popolo. Alla radice di essa c’è il “Popolo di Dio” come viene espresso dalla Rivelazione cristiana. Papa Francesco lo spiega chiaramente fin dai primi tempi del suo pontificato, nell’udienza generale del 12 giugno 2013: i suoi membri sono, tutti insieme, come scrive la Prima Lettera di Pietro: “la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa” (1 Pt 2,9). Questo Popolo intero – e non alcuni privilegiati dentro di esso, sottolinea il Papa citando il Catechismo (n° 783) – partecipa alle tre funzioni di Cristo, che è “Sacerdote, Profeta e Re”. Al suo interno si articolano tutti i diversi compiti e ministeri, compreso quello del Vescovo di Roma.
Questa visione della dignità del “Popolo di Dio”, che la cultura cristiana trasmette nel corso dei secoli alla storia umana, aiuta a cogliere la dignità di ogni popolo della Terra. In tale prospettiva, la politica dev’essere espressione di tale popolo e deve mettersi al suo servizio.
Papa Francesco ha applicato prima di tutto a sé stesso questa convinzione dottrinalmente fondata quando, appena eletto la sera del 13 marzo 2013, si presentò ai suoi “fratelli e sorelle” come vescovo di Roma: “E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – prima, vi chiedo un favore: prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me […]”. E solo dopo la preghiera del popolo egli sentì di poter compiere il gesto del Pastore universale: “Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà”.
È evidente che Francesco non ha mai messo in discussione la Gerarchia della Chiesa e ha rispettato le regole che la Chiesa si è data per l’elezione del Pontefice. Il popolo di Dio e tutti i popoli viventi nelle comunità politiche infatti, non governano direttamente, contrariamente a ciò che tutti i populismi sostengono. Ma egli ha sentito la necessità di ricevere una benedizione da Dio che solo il Suo popolo poteva chiedere. Questo atto è rivoluzionario, ma è anche originario, nel senso dell’esperienza nativa della Chiesa, che il Nuovo Testamento chiama anche adelphotès, comunità di fratelli. È chiaro che un Papa che si presenta in questo modo non riscuote le simpatie di coloro gestiscono il potere politico come se non avessero bisogno né di un mandato né di rendere conto.
Per questo la politica, nel pensiero di Francesco, dev’essere fraterna, intendendo la fraternità in campo politico non in maniera intuitiva o affettiva, ma come un principio regolatore dei progetti politici, come emerge fin dal Messaggio per la 47a Giornata mondiale della pace del primo gennaio 2014.
Non c’è affatto populismo nel pensiero di Francesco: per lui infatti, sulla scorta delle conquiste teoriche del pensiero sociale cattolico latinoamericano così come viene espresso, ad esempio, da Juan Carlos Scannone, il popolo è una realtà unitaria, ma intrinsecamente plurale. Per questo Francesco interpreta l’azione politica dei cittadini come esercizio di “amicizia sociale”. Non c’è improvvisazione, né ingenuità o pacifismo ingenuo in questa idea che egli propone come metodologia politica e attuazione della “cultura dell’incontro” a partire dall’interno delle comunità politiche, dove coesistono diversità di interessi e di visioni politiche, fino alle relazioni internazionali. Egli argomentò adeguatamente questa idea all’Avana, il 20 settembre 2015, parlando ai giovani davanti all’Istituto Varela, esortandoli non solo a sognare, ma a condividere i loro sogni, andando aldilà delle diverse convinzioni per pensare una società migliore.
Quest’idea riprende certamente l’antica idea della “amicizia politica” che Aristotele definiva come quel legame tra i cittadini che caratterizza la ricerca del bene comune. Ma la inserisce nel dinamismo proprio della fraternità politica, che vuole costruire la comunità politica garantendo sia la libertà che l’uguaglianza.
Forse, coloro che pensano che Papa Francesco abbia dato un contributo “pastorale”, ma non dottrinale, alla Chiesa del nostro tempo, dovrebbero intraprendere una riflessione ulteriore.
Antonio Maria Baggio